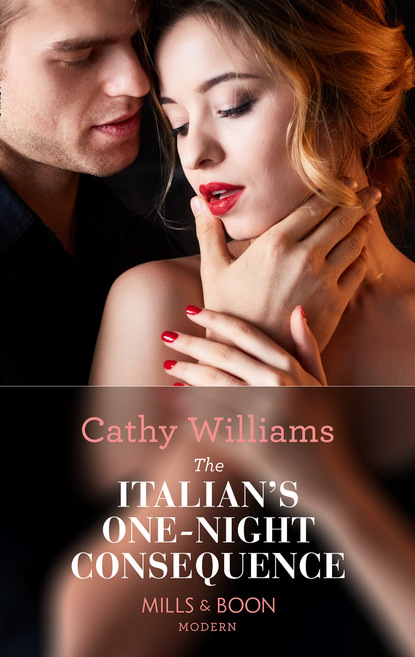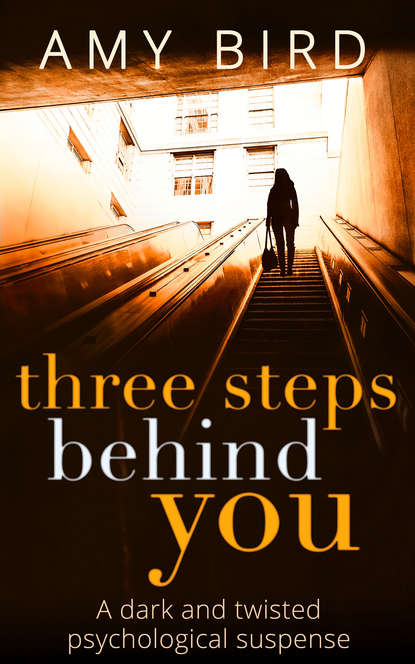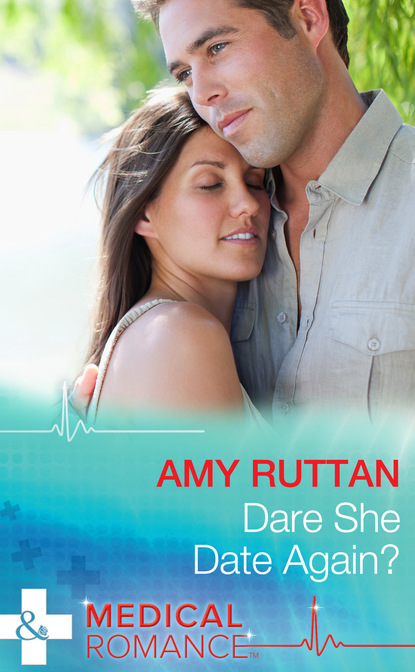- -
- 100%
- +
“Non mi piace pensarci,” disse Luke. “Ho sparato a quel rinoceronte.”
Don lo indicò. “Giusto. Me n’ero dimenticato. Il rinoceronte ci ha caricati. Riesco ancora a vederlo sotto la luce della luna. Però ci siamo arrampicati fuori, zuppi, e abbiamo squarciato la gola di quel bastardo sanguinario – gli abbiamo decapitato tutta la squadra con un solo rapido e decisivo colpo. E non abbiamo torto un capello a nessuno dei bambini. Sono stato orgoglioso dei miei uomini, quella notte. Sono stato orgoglioso di essere americano.”
Luke annuì di nuovo, quasi sorrise. “È stato molto tempo fa.”
“Per me è stato ieri,” disse Don. “Ho appena cominciato a scriverlo. Domani aggiungo il rinoceronte.”
Luke non disse nulla. Era stata una missione, una delle tante. L’autobiografia di Don sarebbe stata un libro lungo.
“E qual è il punto,” disse Don. “Qui non è male. Il cibo non è neanche cattivo – be’, non è cattivo come ci si potrebbe aspettare. Ho i miei ricordi. Ho una vita. Ho messo su una routine di esercizi fisici che per la maggior parte posso fare qui, nella cella. Squat, pushup, chin up, persino posizioni yoga e tai chi. Ho una sequenza, e la eseguo per ore ogni giorno, cambio velocità, la inverto. Ha anche una componente mentale. Credo che darebbe il via a dei patiti del fitness, se la gente la conoscesse. Vorrei registrarla – Prison Power. Mi ha messo in una forma migliore di quando ero fuori nel mondo, libero di fare tutto ciò che mi pareva.”
“Okay, Don,” disse Luke. “Questa è la tua villa per la pensione. Carino.”
Don sollevò una mano. “Voglio vivere, è questo che ti sto dicendo. Mi faranno l’iniezione. Lo sai tu e lo so io. Non voglio l’iniezione. Senti, sono realistico. Lo so che non otterrò la grazia, non nell’attuale ambiente politico. Ma se l’informazione che ti ho dato darà risultati, voglio che la presidente commuti la mia in una sentenza a vita senza la possibilità della condizionale.”
Luke era irritato dall’incontro. Don Morris se ne stava seduto su quello che consisteva in un bagno di pietra, a scrivere le sue memorie e a sviluppare ciò che sperava sarebbe diventata una passeggera moda nel fitness. Patetico. Luke una volta vedeva Don come un grande americano.
La valvola di controllo del sangue di Luke passò da caldo a incandescente. Aveva i suoi problemi, e la sua vita, ma ovviamente a Don non importava tanto. Don era diventato il centro del suo personale universo, lì dentro.
“Perché lo fai, Don?” Indicò la cella. “Cioè…” Scosse la testa. “Guarda questo posto.”
Don non esitò. “L’ho fatto per salvare il mio paese, e lo rifarei. Thomas Hayes era il presidente peggiore dai tempi di Herbert Hoover. Su questo non ho dubbi. Ci stava portando sottoterra. Non aveva idea di come proiettare il potere dell’America nel mondo, e non aveva la propensione a farlo. Pensava che il mondo si prendesse cura di sé. Si sbagliava. Il mondo NON si prende cura di sé. Ci sono forze oscure allineate contro di noi – vanno fuori controllo se per un secondo non le guardiamo. Si fanno posto nel vuoto di potere che lasciamo loro. Vittimizzano il debole e l’inerme. I nostri amici perdono la fede. Io non potevo più restare in attesa e lasciare che accadessero queste cose.”
“E che cosa hai ottenuto?” disse Luke. “Il paese lo sta gestendo la vicepresidente di Hayes.”
Don annuì. “Giusto. E lei ha un paio di cojones più grossi di lui. La gente a volte ti sorprende. Non sono scontento di avere Susan Hopkins come presidente.”
“Ottimo,” disse Luke. “Glielo dirò. Sono sicuro che sarà deliziata di sentirlo. Don Morris non è scontento della tua presidenza.” Si alzò. Era pronto ad andare. Quel piccolo incontro avrebbe dato molto su cui riflettere.
Don saltò giù dal letto. Mise di nuovo la mano sulla spalla di Luke. Per un attimo Luke pensò che Don avrebbe buttato fuori qualcosa di emotivo, qualcosa che Luke avrebbe trovato imbarazzante, come, “Non andare!”
Ma Don non lo fece.
“Non ignorare quello che ti ho detto,” disse. “Se è vero, abbiamo problemi. Anche una sola arma nucleare nelle mani dei terroristi sarebbe la cosa peggiore a cui si può pensare. Non esiteranno a usarla. Un lancio di successo e il genio è fuori dalla bottiglia. Chi se la becca? Israele? E chi colpiscono quelli con le loro testate? L’Iran? Come si mette il freno a questa cosa? Si chiede un time out? Ne dubito. E se veniamo colpiti noi? O i russi? O entrambi? E se viene innescata una serie automatica di rappresaglie? Paura. Confusione. Fiducia zero. Uomini nei silos, le dita che si agitano, a indugiare sopra al pulsante. Ci sono molte armi nucleari ancora sulla Terra, Luke. Una volta che cominciano i lanci, non c’è una buona ragione per fermarli.”
CAPITOLO SEI
20 ottobre
3:30
Georgetown, Washington, DC
Un pick-up nero lo stava seguendo.
Luke aveva preso un volo notturno per tornare. Adesso era stanco – esausto – però ancora iperattivo e sveglio. Non sapeva quando avrebbe dormito di nuovo.
Il taxi lo aveva scaricato di fronte a una fila di belle brownstone. Le strade a tre corsie erano silenziose e vuote. Sembravano luccicare nella luce delle lampade barocche. Mentre il taxi se ne andava, lui se ne stava in piedi sulla strada ad assaporare la notte fredda. Gli alberi stavano perdendo le foglie – erano ovunque per terra. Mentre osservava, ne scesero delle altre.
Dall’aeroporto, era venuto dritto alla casa di Trudy. Le ombre erano tirate, ma almeno sulla strada era accesa una luce a livello dell’appartamento. Non c’era nessuno in casa – le luci chiaramente erano comandate da un timer, probabilmente un timer di poco prezzo preso in un negozietto. Lo schema era sempre lo stesso. Trudy doveva averlo impostato prima di andarsene.
Il posto era ancora suo – Luke questo lo sapeva. Swann aveva hackerato il suo conto in banca. C’erano dei pagamenti automatici per il mutuo, le tasse per il mantenimento dell’immobile e l’elettricità. Aveva pagato in anticipo due anni di tasse sull’immobile stimate.
Era scomparsa, ma l’appartamento c’era, che procedeva per conto suo come se non fosse accaduto nulla.
Perché continuava ad andarci? Pensava che improvvisamente una notte sarebbe stata a casa? Pensava che i mesi passati si sarebbero cancellati da soli?
Si fermò per qualche secondo soltanto, distogliendo lo sguardo dal pick-up, immaginandoselo lì dietro, ricordandoselo nel momento in cui, qualche istante prima, l’aveva superato a piedi.
Era ampio, resistente, il tipo di furgone che si vedeva sui siti edili. I finestrini della cabina erano affumicati, rendendo impossibile vedere granché dell’interno. Anche così aveva la sensazione che ci fossero due ombre dietro quei finestrini. I fanali del furgone erano spenti quando prima lo aveva superato, ed erano ancora spenti – non c’erano state luci in avvicinamento ad avvertirlo. Quello che aveva tradito il furgone era stato il rumore. Riusciva a sentirne il motore brontolare.
C’erano un distributore di benzina e un negozietto sul fondo della collina. Le luci esterne erano accese, sopra alle pompe, ma il negozio sembrava essere chiuso. Luke si portò al centro della strada, verso la luce che lo chiamava.
Guardò alla sua sinistra e alla sua destra senza girare la testa. Su ogni lato erano parcheggiate auto costose una dietro l’altra contro al marciapiede in una linea continua. Era un quartiere affollato, e non c’erano molti parcheggi. Non c’era un modo ovvio di lasciare la strada per salire sul marciapiede.
Scattò.
Lo fece senza avvisaglie. Non accelerò gradualmente dalla camminata alla corsa. Un attimo stava camminando, e un battito di ciglia dopo stava correndo più veloce che poteva. Dietro di lui, il pick-up ruggì. Le ruote bruciarono le gomme sull’asfalto, lo stridio delle ruote che squarciava la notte silenziosa.
Luke si tuffò a destra, scivolando di testa sul cofano di una Lexus bianca. Scivolò giù dall’auto e ruzzolò sul marciapiede, atterrando sulla schiena, rotolando in posizione seduta mentre estraeva la Glock dalla fondina a spalla dentro la giacca, tutto in una mossa sola.
La Lexus cominciò a disintegrarsi dietro di lui. Il furgone si era fermato, e il finestrino del passeggero era stato abbassato. C’era un uomo con una maschera da sci che sparava da un fucile automatico con un soppressore di suono gigantesco. L’arma aveva attaccato sul fondo un caricatore a tamburo, probabilmente dodici dozzine di proiettili. Luke assorbì tutte quelle informazioni in un istante, prima che la mente cosciente ne fosse anche solo consapevole.
I finestrini della Lexus si infransero, le gomme scoppiarono e la macchina affondò a terra. TANK, TANK, TANK – i proiettili ne colpivano i pannelli esterni. Del fumo si alzò da sotto il cofano. L’uomo del furgone lo stava crivellando con la mitragliatrice.
Luke corse in avanti, abbassandosi. I proiettili lo seguirono, mandando in frantumi la macchina successiva come avevano fatto con la Lexus. Del vetro gli si sparpagliò addosso.
Partì l’allarme di una macchina, suonò per cinque secondi, poi si fermò quando i proiettili perforarono il veicolo e distrussero il sistema di allarme.
Luke continuò a correre, il fiato bollente nei polmoni. Raggiunse il distributore e scattò attraverso l’ampio spiazzo aperto. Le luci gettavano delle ombre inquietanti – le pompe sembravano mostri incombenti. Il pick-up sbandò nel parcheggio dietro di lui. Luke si voltò indietro e lo vide rimbalzare sul marciapiede e fare una curva stretta.
Corse giù per un’altra stradina, poi sfrecciò a sinistra in un vicolo. Era una vecchia strada di ciottoli. Incespicò sulla superficie ruvida e butterata. Il motore del furgone gridò, vicinissimo. Luke non guardò. Giunse un cigolante scricchiolio quando il furgone rimbalzò sui ciottoli.
Luke lo sentiva lì – il furgone si trovava un secondo solo dietro di lui.
Il cuore gli martellava nel petto. Non serviva a niente. Girò la testa e c’era il furgone, proprio dietro di lui. La massiccia griglia si fiondava in avanti, facendosi sempre più grande a mano a mano che si avvicinava. Sembrava un’immensa bocca sorridente. Il cofano del furgone era quasi alto quanto la sua testa.
Alla sinistra di Luke c’era un cassonetto dell’immondizia. Lo percepì, più che vederlo. Ci si tuffò dietro, cadendo sui ciottoli, atterrando malamente in un’alcova minuscola. L’impatto gli scosse le ossa, e lui si schiacciò contro al muro, tanto stretto quanto gli permetteva il suo corpo.
Un istante dopo, il pick-up caricò il cassonetto, mandandolo a sbattere contro il muro del vicolo. Il furgone passò, mancando appena Luke, trascinandosi dietro il cassonetto. Sbandò e si fermò nel vicolo quindici metri dopo l’alcova. Le luci dei freni brillarono di rosso. Il cassonetto era schiacciato tra la portiera del conducente e il muro.
Luke poteva riprendere l’iniziativa, ma per farlo doveva muoversi.
“Alzati,” disse.
Si trascinò in piedi, arma in mano, e incuneò il proprio corpo nell’alcova. Con due mani, mirò al lunotto posteriore del furgone.
BLAM, BLAM, BLAM, BLAM.
Il lunotto andò in pezzi. Il rumore dell’arma fu assordante. Riecheggiò giù per il vicolo e fuori nelle strade silenziose della città. Se fosse stato in cerca di attenzioni, e così era, ecco che sarebbero arrivate.
Le ruote del furgone urlarono e si triturarono sui ciottoli mentre il conducente cercava di liberarsi dal cassonetto.
Il passeggero – il tiratore – usò il calcio dell’arma per infrangere i resti del lunotto. Avrebbe tentato di sparare.
Perfetto.
BLAM.
Luke gli sparò, facendo centro in fronte.
L’uomo crollò, la testa a penzolare fuori dal lunotto, l’arma a sferragliare inutilmente sul pianale del pick-up.
Il furgone sbandò di lato, la griglia che scivolava lungo il muro, il lato del conducente che adesso era proprio davanti a Luke. Luke avrebbe preso anche lui, se avesse potuto, ma non con un colpo mortale. Lo avrebbe tenuto in vita perché rispondesse a delle domande.
Il conducente era bravo – più del suo amico. Il suo finestrino era andato in frantumi con la collisione, ma lui si era accucciato. Luke non riusciva a vederlo.
BLAM, BLAM, BLAM.
Luke tirò tre colpi nella portiera del conducente. Il rumore fu vuoto, metallico, quando i proiettili la attraversarono. Il conducente urlò. Era stato colpito.
Improvvisamente il furgone sbandò verso destra, come un ladro di automobili che disegna ciambelle sulla neve. Il pianale oscillò e colpì il muro. Ma il furgone si era liberato dal cassonetto. Se il conducente ne fosse stato ancora in grado, era libero di scappare.
Luke mirò alla ruota posteriore sinistra. BLAM.
La ruota scoppiò, ma il furgone stridette e partì nel vicolo. Rimbalzò in strada, sbandò, e andò a sinistra. Sparito.
Nelle vicinanze, le sirene si stavano già avvicinando. Luke riusciva a sentirle venire da diverse direzioni. Rinfoderò la pistola e claudicò fuori dal vicolo, il ginocchio che già si stava irrigidendo. Se lo era scorticato cadendo sui ciottoli.
Un’Interceptor della polizia di Washington ruggì, le luci che splendevano e gettavano assurde ombre azzurre contro gli edifici circostanti. Luke aveva già estratto il distintivo, il vecchio distintivo del defunto Special Response Team dell’FBI. Aveva ancora un anno di vita prima della scadenza. Sollevò le mani bene in alto, il distintivo nella mano destra.
“Agente federale!” urlò ai poliziotti che si precipitarono fuori dalla macchina ad armi spianate e puntate su di lui.
“A terra!” gli dissero.
Lui fece esattamente come avevano detto, movendosi lentamente e con attenzione, senza minacciare nessuno.
“Che sta succedendo qui?” disse uno dei poliziotti afferrando il distintivo dalla mano tesa di Luke.
Luke fece spallucce.
“Qualcuno sta cercando di uccidermi.”
CAPITOLO SETTE
10:20
Casa Bianca, Washington, DC
Era come un funerale di Stato, la grande apertura di un parcheggio di auto usate e lo show di un comico amatoriale tutto in una volta.
Susan Hopkins, la presidente degli Stati Uniti, con addosso un abito e uno scialle blu fatti apposta per l’occasione dalla stilista Etta Chang, guardò oltre il prato a sud i dignitari e giornalisti raccolti. Era un gruppo selezionato, e l’invito più difficile da ottenere in città nell’ultimo mese. In una soleggiata e brillante giornata autunnale, sotto il cielo azzurro, la Casa Bianca – uno dei più duraturi simboli d’America – era ricostruita e pronta all’uso.
Gli uomini dei servizi segreti torreggiavano dietro e davanti a Susan, levando linee di tiro – le sembrava quasi di essere perduta in una foresta di uomini alti. Washington, DC, la Virginia e il Maryland erano zone soggette a restrizione dello spazio aereo quella mattina. Se non si era atterrati entro le sette del mattino, si era sfortunati.
La cerimonia si stava allungando. Era cominciata appena dopo le nove, e si stava già dilungando oltre le dieci e mezza. Tra la processione militare d’apertura con il trombettiere che suonava il silenzio e il cavallo senza cavaliere in onore di Thomas Hayes, la liberazione di uno stormo di colombe bianche a simboleggiare i molti altri che quel giorno e quella notte erano morti, il sorvolo del jet da combattimento, il coro dei bambini e discorsi e benedizioni varie…
Ah sì, le benedizioni.
La casa ricostruita era stata benedetta, a turno, da un rabbino ortodosso di Philadelphia, un imam musulmano, l’arcivescovo cattolico di Washington, DC, il ministro dell’AME Zion Church di North Capitol Street e il famoso monaco buddista nonché attivista pacifista Thich Nhat Hanh.
L’alterco che era nato al momento della scelta dei dignitari religiosi – già quello da solo aveva amareggiato Susan per l’evento. Un rabbino ortodosso? Il gruppo delle donne per un giudaismo riformato aveva dato voce al proprio fastidio – avevano spinto per una rabbina donna. Un sunnita o uno sciita per l’imam – non li si potevano accontentare entrambi. Anzi, Kat Lopez li aveva fregati entrambi e aveva scelto un sufi.
I gruppi cattolici non erano entusiasti di Pierre. Il primo uomo degli Stati Uniti era gay? E sposato con una donna? Cani e gatti che giacevano insieme. Quella questione fu risolta quando Pierre decise di prendersi un permesso e guardare l’evento dal suo appartamento di San Francisco.
Pierre e le ragazze erano ampiamente scomparse dalla vita pubblica dallo scandalo. Era giusto tenere le ragazze lontane dai riflettori dopo tutto ciò che era accaduto, ma quello era un evento importante e Pierre non era neanche voluto venire. La cosa preoccupava un po’ Susan. In realtà, più di un po’. E, ovviamente, adesso gli attivisti per i diritti dei gay erano furiosi con lui per ciò che loro vedevano come un inchinarsi alle pressioni della Chiesa cattolica.
Sul podio Karen White, la nuova presidente della Camera, stava appena finendo il suo discorso. Karen era eccentrica, per usare un eufemismo – indossava un cappello con sopra un grosso girasole di carta. Il cappello era più appropriato per una caccia alle uova di Pasqua da bambini che per l’evento di quel giorno. Se Etta Chang lo avesse visto, sarebbe stata ora di un bel cambio di stile.
Le annotazioni di Karen erano state rapidi affondi contro i liberali al governo – grazie a Dio, perché alle elezioni speciali per ricostituire il Congresso decimato mancavano due settimane. Le campagne si erano trasformate in assurdi battibecchi pieni di odio – gli storici si divertivano ad andare sui notiziari della CNN e della FOX ad affermare che nel paese il discorso civile aveva raggiunto il suo più basso declino dai tempi della Guerra civile.
Ciò che a Karen White mancava in retorica offensiva sul fronte interno, riusciva a crearlo benissimo sul palco mondiale. Il suo discorso sembrava suggerire – col trasalimento di molti, nel pubblico – che la Casa Bianca fosse stata distrutta non da furfanti del movimento conservatore e dell’esercito degli USA, ma da agenti stranieri, probabilmente iraniani o russi. Durante un passaggio logicamente tortuoso, lo speciale emissario dell’Iran si era alzato in piedi e se n’era andato via, imbufalito, con al seguito due dei suoi diplomatici.
“Va tutto bene,” disse all’orecchio di Susan Kurt Kimball, il consigliere per la sicurezza nazionale. “Lo sanno tutti che Karen è un po’ bizzarra. Cioè, la guardi. Chiameremo qualcuno del dipartimento di Stato a sistemare le cose per loro.”
“Come?” chiese Susan.
Fece spallucce. “Non lo so. Ci inventeremo qualcosa.”
Sul palco, Kat aveva rivolto a Susan un cenno. Erano pronti per lei. Uscì sul palco mentre gli agenti dei servizi segreti si mettevano in posizione attorno a lei. Il podio era circondato su tre lati da vetro trasparente antiproiettile. Restò un attimo lì a esaminare la folla assemblata. Non era per nulla nervosa. Parlare con la gente era sempre stato uno dei suoi punti di forza.
“Buongiorno,” disse. La voce riecheggiò per tutto il prato.
“Buongiorno,” le urlò di rimando qualche simpaticone.
Si lanciò, a suo agio, nel discorso preparato. Era un buon discorso. Parlò col pubblico di sacrificio condiviso, e di perdita, e di resilienza. Disse della grandezza dell’esperimento americano – cosa che sapevano già. Disse del valore degli uomini che quella notte le avevano salvato la vita, e riconobbe Chuck Berg – che adesso era a capo del distaccamento della sicurezza di casa sua, e si trovava sul palco con lei – e Walter Brenna, che era un ospite d’onore della prima fila. Entrambi gli uomini sollevarono le mani e ricevettero un tumultuoso applauso.
Disse che si sarebbe trasferita nella Casa Bianca quello stesso giorno – il che portò a una standing ovation – e che li avrebbe accolti all’interno dopo le sue annotazioni per fare un giro e vedere che cosa aveva fatto del vecchio posto.
Terminò con una fiorettatura, facendo eco a quel grande eroe che era per lei, e per tutti, John Fitzgerald Kennedy.
“Quasi sessant’anni fa, John Fitzgerald Kennedy è stato eletto presidente. Il suo discorso inaugurale è uno dei più fantastici e citati mai tenuti. Tutti voi sapete che in quel discorso ci ha detto di chiederci non cosa il nostro paese può fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per il nostro paese. E sapete una cosa? C’è un’altra parte di quel discorso, meno conosciuta, che mi piace altrettanto. Sembra particolarmente appropriata agli eventi di oggi, e voglio lasciarvi con quelle parole. Ecco cos’ha detto Kennedy.”
Fece un respiro profondo, sentendo nella testa le pause che si era preso Kennedy. Voleva ripetere l’esatta formulazione.
“Facciamo sapere a ogni nazione,” disse, “che ci auguri il bene o il male… che pagheremo qualsiasi prezzo… ci addosseremo qualsiasi peso…”
Nella folla, l’esultanza era già cominciata. Lei agitò una mano, ma non servì. Avrebbero fatto così, e il suo lavoro adesso era andare incontro al gonfiarsi crescente della loro esplosione, in qualche modo prenderne le redini e portarlo fino al traguardo.
“Affronteremo qualsiasi avversità…” urlò.
“Sì!” urlò qualcuno, in qualche modo tagliando il rumore.
“Supporteremo qualsiasi amico,” disse Susan, e sollevò il pugno in aria. “E andremo contro ogni nemico… per assicurarci la sopravvivenza e il successo della libertà!”
La folla era salita in piedi. L’ovazione andò avanti.
“Questo promettiamo,” disse Susan. “E altro.” Fece un’altra pausa. “Grazie, amici. Grazie.”
* * *
L’interno dell’edificio le dava i brividi.
Susan si spostò per i corridoi con il suo contingente dei servizi segreti, Kat Lopez, e due assistenti che la seguivano. Il gruppo superò le porte dello Studio Ovale. Solo trovarsi lì su di lei aveva un effetto strano. Lo aveva già sentito, appena una settimana prima, quando per la prima volta le avevano fatto fare il giro della Casa Bianca rinnovata. C’era un che di surreale nella cosa.
Non era cambiato quasi niente. In parte si trattava di questo. Lo Studio Ovale sembrava lo stesso dell’ultima volta che l’aveva visto – il giorno in cui era stato attaccato e distrutto, il giorno in cui Thomas Hayes e più di trecento persone erano morte. Tre alte finestre, con le tende tirate, che ancora davano sul giardino delle rose. Vicino al centro dell’ufficio, si trovava un comodo salottino su di un lussuoso tappeto adornato con il sigillo del presidente. Persino la Resolute Desk – un dono vecchissimo del popolo britannico – era ancora lì, al suo solito posto.
Certo, non era la stessa scrivania. Era stata ricostruita a mano a partire dai disegni originali a un certo punto negli ultimi tre mesi in una falegnameria della campagna gallese. Ma era questo il punto per lei – tutto sembrava esattamente uguale. Era quasi come se il presidente Thomas Hayes – più alto di chiunque attorno a lui di almeno dieci, undici centimetri – potesse entrare in qualsiasi istante e rivolgerle il suo solito cipiglio.
Era traumatizzata? La innervosiva, quell’edificio?
Sapeva che avrebbe preferito vivere all’Osservatorio navale. Quella maestosa casa antica era stata casa sua negli ultimi cinque anni. Era luminosa, aperta, e ariosa. Lì si trovava a suo agio. In confronto la Casa Bianca – soprattutto la residenza – era scricchiolante, eccentrica, malinconica e piena di spifferi in inverno, con una pessima luce.
Era un posto grande, ma le stanze sembravano anguste. E c’era… qualcosa… in quel luogo. Sembrava di poter svoltare l’angolo e imbattersi in un fantasma. Un tempo pensava che sarebbe stato il fantasma di Lincoln o McKinley o persino Kennedy. Ma adesso sapeva che sarebbe stato Thomas Hayes.
Si sarebbe ritrasferita all’Osservatorio navale in un battito di ciglia – se solo non l’avesse ceduto. La sua nuova vicepresidente, Marybeth Horning, ci si sarebbe dovuta trasferire nei prossimi giorni. Sorrise quando pensò a Marybeth – la senatrice ultraliberale del Rhode Island – che il giorno dell’attentato a Mount Weather era in viaggio d’inchiesta sulle violazioni dei diritti civili in aziende agricole che producevano uova dell’Iowa. Marybeth era un’aizzatrice per i diritti dei lavoratori, quelli delle donne, dell’ambiente, per tutto ciò di cui importava a Susan.