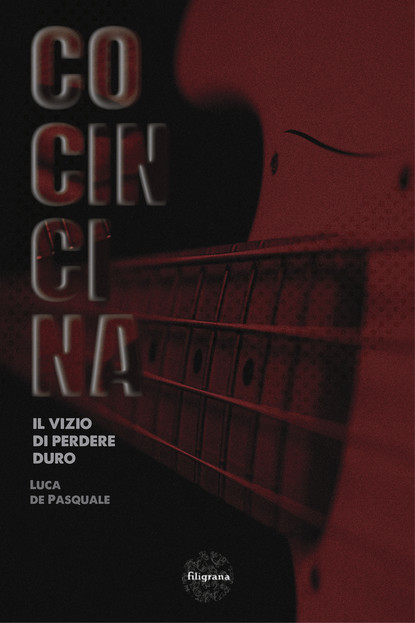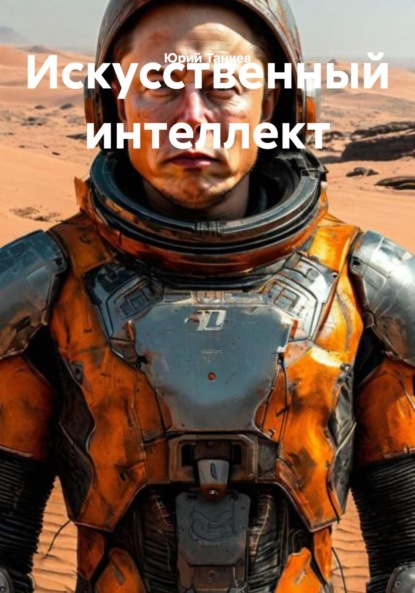- -
- 100%
- +
Qualcosa mi dice che dovrei sentirmi umiliato da questa situazione, se non altro dovrei sentirmi in imbarazzo. Il bisognoso che va agli sportelli di un CAF, l’ennesimo, a informarsi su come sbarcare almeno i prossimi due mesi.
Invece, mi sento neutro. Incolore, in transito, e questo non è altro che un ennesimo piccolo spostamento di pigre e incredule speranze. Guardo la donna che ho di fronte indugiando di più sui dettagli; noto che ha scelto un taglio di capelli carrè, faccio caso alla fede quasi etnica che porta alla mano sinistra. Mi soffermo poi sull’avvocatessa, immersa in mille carte e persa nella sigaretta, che le siede al fianco. La stanza è bianca e pulita. C’è un grosso mobile semivuoto e io sono seduto qui, sul posto accordato ai disperati, ai bisognosi, a quelli che qui ci arrivano grazie ai rovesci della vita, alle malversazioni non più scongiurate. Penso che ho quarantacinque anni, sicuramente vari più di lei, un’impiegata, una dipendente come me sino a qualche anno fa che però mi tratta come un ragazzino un po’ sfortunato.
Non riesco nemmeno a compatirmi. Piuttosto, mi viene da sbadigliare e vorrei alzarmi di botto, salutare sobriamente e sparire.
«Grazie Mariarca, salutami Rosa. Allora, adesso informo il ragazzo... ciao bella, a presto... non lavorare troppo!»
Non sia mai.
«Mi dica, allora.»
«Allora, visto che non hai proprio niente, puoi tentare di avere accesso alla Carta Quartierale del Bisogno, solo che la domanda si può inviare solo tre giorni all’anno e siamo pericolosamente vicini a questa data...»
«Benissimo.»
«... altrimenti, sempre perché sei sotto la soglia della povertà consentita, potresti cercare di entrare nella graduatoria di quelli denominati “Esubero Dell’Età Di Mezzo Senza Prole Senza Mezzi”, detta EDEDMSPSM. Questo servizio assistenziale ti permette di poter disporre di un bonus di 57 euro al mese per i supermercati convezionati...»
«Splendido, solo questo?»
«No, c’è di più! Puoi anche pagare con una SupSpecial Card due bollette Enel l’anno, a tua scelta, e avere uno sconto del 74% su otto medicinali in un anno. Mi sembra già qualcosa...»
«Naturalmente.»
«Per accedere all’EDEDMSPSM, tutto quello che devi fare è produrre alcuni certificati; uno di carichi pendenti, poi estratto di nascita, stato di famiglia, residenza, diploma o laurea, congedo militare, saldo bancario al 31 dicembre dell’anno scorso, l’ultima bolletta Enel e anche quella del gas, infine devi dichiarare quante carte hai, tipo Paypal, Postepay, carte di supermercati, tessere di palestre... dopo questi passaggi possiamo tentare di inoltrare la domanda e dobbiamo incrociare le dita, perché è difficile accedere...»
Prendo tutte le notizie, simulo un vago entusiasmo. Stringo la mano alle due donne. Il ragazzo se ne va. Con il volto parzialmente illuminato da una nuova piccola speranza a forma di card. Ma è una farsa. Faccio così solo perché non ho voglia di uscire da questa stanza mormorando uno stanchissimo «grazie, non fa niente», come è capitato da due anni a questa parte.
Se non sei più giovane o ancora vecchio, perdere il lavoro in Italia e non ritrovarlo è una colpa, una macchia, un errore. Hai sbagliato di sicuro qualcosa. Magari non sei stato furbo. Non hai coltivato le persone giuste. Non hai finto, neppure quello, di leccare natiche. Non hai creduto in te stesso, magari. Non sei espatriato, eppure era così facile! E sei stato tanto fesso da non aver fatto credere di votare per quel politico che conosceva tuo zio o tua nonna... Alla fine ti danno dell’idealista, dello sfigato o dello stronzo bipolare: quel che è certo è che la colpa ti appartiene. Da quello non puoi fuggire. E allora tu decidi di fare branco da solo, e come i lupi feriti ma vigili ti nascondi nella neve, che quella piace ai bambini, non avranno paura di te.
Esco dal palazzo, saluto il portiere come se fosse il mio migliore amico, svicolo velocemente nella folla. Il pacchetto di Camel è quasi vuoto. Il ragazzo-lupo fuma le Camel, finché potrà permetterselo. Le strade, la folla, il caldo, le auto sporche con i gomiti da fuori, sono tutte sbarre quando manca la libertà essenziale di bastare a se stessi. E nella libertà, insindacabile e sacra, rientra anche il poter evitare di raccontare di una caduta personale a estranei disattenti e quasi sempre impotenti.
Arriva l’estate, signori.
Leggerò di food blogger, di fashion blogger, di imprenditori con la luce in bocca, di welfare e di eleganti giovani presidenti, leggerò di star della televisione finite malvolentieri nelle forche caudine del tetto dei compensi.
Leggerò dei libri che sono stati scritti su eleganti scrivanie, su portatili color crema. Con capitoli che sono stati festeggiati con scopate e uscite. Leggerò storie costruite a tavolino su solidarietà e inclusione sociale. Continuerò a sorridere alla gente.
Come un lupo al quale la vista inizierà a far difetto, finirò per attaccare la mia ombra in una notte qualsiasi, una notte troppo calda per aspettare il mattino seguente.
IV
La bellissima pioggia del 1985
Uno dei miei ricordi più belli è legato a un’atmosfera, come spesso accade; quella di un tardo pomeriggio di tantissimi anni fa, precisamente nel freddo novembre del 1985. Ero uscito sotto il diluvio per recarmi all’oasi heavy metal del mio quartiere, Godzilla, lungo la malinconica via Crispi e che torna spesso nei miei aneddoti vintage.
Nonostante le esagerate implorazioni dei miei genitori, e in particolare di mio padre, che non volevano uscissi sotto la pioggia battente, indossai il mio datato giubbotto nero e grigio e andai alla ventura, fresco di paghetta per comprare un vinile metal. La città sembrava deserta. I napoletani non amano la pioggia, è risaputo. Si spaventano per quattro gocce e rinunciano facilmente. Io invece la pioggia la amo, adoro il tempo piovoso e anche il vento che sferza la faccia, sono una strana creatura del Sud. Infatti per me Napoli è meravigliosa sotto i temporali, è una città gotica e misteriosa, la mia cupissima Gotham dei miracoli rispediti al mittente. Sole, mare e pizze non fanno al caso mio.
In venti minuti, fradicio e ansante, ero al negozio. Acquistai un vinile degli Attacker, Battle At Helm’s Deep, un ottimo disco di heavy/power metal americano, copertina orripilante, votata negli anni successivi come una delle peggiori del genere e non solo. Perché lo compravo? Per spirito di contraddizione. Perché mi piaceva il power a stelle e strisce. E perché mi colpiva il nome della band e l’iconografia non proprio vincente dell’artwork.
Pagai il disco e uscito dal negozio, lì iniziò la dose di magia che non ho mai dimenticato. Per via Crispi c’ero solo io, sotto scrosci torrenziali di acqua deviata dal vento. Lampioni tremolanti con luce giallognola, le finestre accese nelle case. Mi trovai solo, fuori al negozio, che ricordo aveva un’insegna verde. Mi sentii profondamente, totalmente libero. Giovane. E ingenuo. Tutte le aspettative della mia serata erano in quell’oscuro disco degli Attacker, e a me andava benissimo così. Speravo anche di trovare all’interno una di quelle ballate drammatiche e arpeggiate che tanto amavo e che poi i Queensrÿche (The lady wore black, I dream in infrared) mi avrebbero elargito di lì a poco a piene mani. Avevo una gran voglia di innamorarmi, anche e soprattutto non ricambiato, perché mi sembrava un cammino più interessante da percorrere. Certo, avevo freddo e il vento mi tagliava le labbra, ma è quella l’atmosfera – lo penso ancora oggi – che può spingere un uomo a innamorarsi sul serio, non importa se per sempre.
Quale era il nome della ragazza che mi era destinata? E quale nome avrei dato allo struggimento, alla mia età, al coraggio delle tempeste che – ne ero certo – mi avrebbe spinto a scrivere tutta la vita? Le risposte transitavano in quell’atmosfera da tregenda atmosferica, sotto l’instabile e pencolante insegna di quel negozio di nicchia, in quella magnifica e decadente strada deserta. La città era dunque ai piedi della mia giovinezza, della mia incoscienza e anche del mio amore assolutista per la musica tutta, a iniziare proprio dall’heavy metal.
Scrivo di quella serata e di quel disco degli Attacker trentaquattro anni dopo. Non ho mai smesso di amare pioggia, vento e dischi. La mia Gotham ormai mi vive dentro, cupa scenografia in cui mi arrogo il puerile diritto di essere sia Batman che il Joker, alternando le maschere a seconda della gradazione del dolore. Sono divorato e dileggiato dal desiderio di anarchia e non mi è affatto estraneo lo scomodo e direttivo abito della vendetta. Il pipistrello giustiziere, il criminale beffardo, l’uomo, gli elementi liberati nella notte. In fondo, da questo punto di vista, non è poi cambiato molto. Fino a poco tempo fa ho continuato a cercare le atmosfere opportune per innamorarmi di qualcuno o di qualcosa, poco importa se non facevano al caso mio. Senza atmosfera, non amo con la garanzia della durata. Una persona mi deve portare e regalare la tempesta che cerco da sempre, non il brivido erotico, non la svogliata comprensione o l’avvolgente concretezza. E questo vale anche per la musica e per le mie scelte, dalle più grandi alle piccolissime. Atmosfera, meglio livida che solare, e mille volte meglio un bacio nelle tenebre che una celebrazione sotto la luce naturale dell’estate.
Erano anni che volevo riacquistare, simbolicamente, quel vinile degli Attacker, finito perso o venduto in chissà quale buco nero dei miei anni di adolescente. Ho sempre ricordato il nome del bassista, chissà come mai: Lou Ciarlo. Un eccellente bassista, per quel che doveva fare in quel contesto.
Ho acquistato Battle at helm’s deep giorni fa, ristampato in vinile verde, più poster, da un’etichetta greca, la Eat Metal Records. Forse me lo metto in cornice. Così come ho incorniciato, come ricordo, il violento e sfacciato coraggio di quegli anni vissuti sotto le insegne malferme di un’epica ingenuità, disarmata e spesso controproducente.
Oggi sono uno dei tanti disillusi e cinici che girano per il mondo, con il mio carico di ferite, di vendette consumate o in preparazione; di amori abortiti, di confessioni interrotte sul più bello, di imprese fallimentari e di rapporti umani andati a puttane senza ombrello. Oggi mi sento il Batman incarnato da Bale, non il Joker. Le tenebre devono fare paura a chi deve averne, e per quanto mi riguarda devono essere l’atmosfera dei regni che sono riuscito a dominare contro ogni previsione esterna. Sì, è vero: uno dei miei grandi difetti è che mi innamoro prima delle atmosfere e poi, e non è detto, del resto. Ma cosa posso farci se mi sento un uomo di vento, e devo quindi cercare i luoghi adatti dove far sentire la mia voce senza essere condannato o fare paura? Il male è restare fermi. Il male è non ricordare le emozioni. Il male è tradirsi per avere accesso a qualcosa che non dovrebbe essere concessione ma sbocco naturale. Come il lavoro, per esempio.
Ma questa è un’altra storia. E allora lunga vita agli Attacker e alla pioggia in cui mi perdo già da ore scrutando il nulla da questa sedia, nelle tenebre tascabili di una nuova stanza lontana dal lontano, che non voglio più.
V
L’effetto Power Play trent’anni dopo
Nel 1988 ero appena un sedicenne. Già da tre anni bazzicavo tanto le sigarette (di mio padre) quanto la musica di Bill Evans, di cui il mio vecchio possedeva alcuni rari 45 giri con Sam Jones al contrabbasso e Philly Jo Jones alla batteria.
Come le sigarette arrivai a consumarli tutti, uno dopo l’altro, fino alla fine e senza alcuna tregua. A sedici anni non potevo certo avere le idee chiare sul mondo del contrabbasso, e nemmeno sulla consecutio dei bassisti che si erano succeduti alla corte di Bill Evans. Scott LaFaro aveva nei fatti demolito le mie timide simpatie per il pop e in quei giorni stavo cercando di approfondire la figura di Eddie Gomez. Inoltre, non avevo la minima idea che il contrabbasso si potesse amplificare e in generale ignoravo ancora troppe cose. Non essendoci Internet, ero principalmente dotato di buona volontà e di quella ostinazione equilibrata che sopraggiunge quando un’ossessione assume un senso ben preciso e addirittura un progetto di conoscenza di lungo termine, seppur poco strutturato.
Nel dicembre del 1988, con mia somma sorpresa, il mio commesso di dischi preferito
(uno dei miei primi formatori) ci tenne a farmi sapere che era appena uscito un disco solista di Eddie Gomez. Mi venne il batticuore.
«E com’è?», gli domandai.
«Terrificante»
«Cioè bellissimo?»
«No, una vera ciofeca»
«Ah... ma come è possibile, scusa?»
«Ci sono dei grandi musicisti, spesso bassisti, che fanno dei dischi solisti bruttissimi. Non te lo consiglio»
«Capisco, ma dov’è? Dov’è, lo voglio vedere!»
Armando mi indirizzò verso lo scaffale “Novità Jazz” e dopo quattro o cinque vinili mi comparve davanti la sorniona faccia latina di Eddie Gomez, accompagnato dal suo contrabbasso e da una bella donna che sembrava respirargli sulla spalla. La copertina era su sfondo violaceo/rosa e il disco si intitolava Power Play.
Non chiesi ad Armando di ascoltarlo. Sfilai direttamente le quindicimila lire dal portafogli e gli dissi che lo avrei portato alla cassa. Non fece una bella espressione, Armando. Sembrava davvero contrariato. Capendo l’antifona, mi sembrò naturale giustificarmi: «Magari hai ragione, tu sei molto più esperto di me, ma qui si sta parlando di un musicista che il contrabbasso lo fa cantare e io SENTO IL DOVERE di acquistare questo vinile, io devo sostenere questo marziano!»
Armando mi sorrise. Devo dirlo, fu un sorriso molto bello. Da fratello maggiore che accettava questa forma di devozione. Già, perché proprio di devozione si trattava, per non dire gratitudine. Eddie Gomez mi aveva sconvolto in You must believe in spring, così come Scott LaFaro mi aveva convinto che la mia anima e quello che ci vagolava dentro potesse avere un suono corrispondente nella realtà, anche se non grazie alle mie mani.
Piazzai il disco di Eddie come un totem sulla piccola scrivania di casa mia. Lo aprii solo dopo una settimana e lo ascoltai con attenzione. Certo, non era propriamente jazz, non somigliava neanche un po’ alla musica di Bill Evans, però mi piaceva. Data l’età e l’inesperienza di ascoltatore, non poteva non piacermi; e il processo di consolidamento della mia ossessione per lo strumento e il suo mondo contribuivano non poco a rendermi scarsamente obiettivo e certamente di parte. Un aspetto da non trascurare riguardava il fascino che esercitava su di me la copertina. E certo. Raffigurava un mio idolo, lo strumento che amavo di più e una bella donna, su sfondo quasi viola. Non potevo chiedere di più.
In questi giorni, trascorso un trentennio da allora, ho riascoltato Power Play con addosso un senso di tenerezza misto a nostalgia. La devozione non è affatto scomparsa, semmai si è rafforzata. Naturalmente, sono consapevole che si trattava di un tentativo, da parte di Eddie, di unire una base ovviamente jazz con nuove e forse poco ponderate esigenze commerciali; in più, avevo rimosso che in questo album il grande bassista portoricano si cimentava addirittura, in un brano, con un basso elettrico verticale, il Merchant Vertical Bass.
So benissimo che Eddie Gomez ha dato in realtà il suo meglio – che è eccelso, tanto per ribadire – in altri contesti, non solo con Bill Evans. Però non riesco a considerare questo disco come uno qualunque, da conservare solo per devozione, appunto. Penso sia una questione di rapporto affettivo, che mi spinge ancora oggi a difenderne strenuamente il valore e la portata, troppo facilmente contestabili, da me in primis.
Amo moltissimo i dischi di contrabbasso solo, l’improvvisazione più selvaggia; il mio approccio uditivo verso il contrabbasso è di marca piuttosto free, un aspetto che potrebbe indurmi a dileggiare questo tipo di operazioni. Certe volte accade che il lavoro di qualche contrabbassista si riveli troppo commerciale o tradizionale per i miei gusti. Che la commistione di moderno e dogmatico mi sia indigesta, e ancor di più che una pulsione troppo “fusionara” mi disturbi addirittura.
Power Play è fuori da questa ambigua galassia, è prima di tutto un tenero ricordo, un caposaldo di una passione vecchia quasi quanto la mia intera esistenza.
Lo stesso discorso potrei anche farlo per un disco di Miroslav Vitous, Majesty Music, che non è certo uno dei suoi più riusciti. Sono i dischi con i quali ho cominciato; sono quelli che hanno sostituito i Duran Duran e gli Spandau Ballet (con tutto il rispetto); gli stessi che mi hanno salvato dalla seccante e vizza dicotomia Beatles/Rolling Stones. Sono i dischi della scoperta, tra i quali, come è ovvio, ci sono dei capolavori che mi hanno cambiato cervello, orecchie e cuore.
Power Play non è e non sarà mai considerato un capolavoro. Ma è mio, mi appartiene come tutte le svolte appartengono agli uomini che hanno la fortuna di viverle.
E così, faccio una pausa dai pensosi e intensi dischi che ho preso ad ascoltare ultimamente, quelli di Moppa Elliott, Bob Magnusson, le collaborazioni del grande Chuck Domanico, la fissazione per il duo Dave Holland/Sam Rivers, Anders Jormin, Barre Phillips, Stefano Scodanibbio, George Mraz e mille altri.
Come in tanti e sfaccettati frangenti della mia vita, compio un viaggio nel passato con curiosità e indulgenza; mi permetto di appassionarmi ancora a qualcosa che non sia finito sotto il setaccio delle rimozioni, delle inversioni di marcia. Qualcosa che neanche il peggior dolore è capace di sporcare: il sogno della musica e di musicisti chini sul loro strumento, intenti a cavarne fuori l’anima troppo a lungo sottovalutata, ignorata e circoscritta.
È stato un anno duro, crudele, e non è ancora finito. Se non avessi più di una passione, sarei alle corde. Se non credessi in quel che faccio, sarei un triste cadavere ambulante. Se non sapessi che l’anima di ogni uomo ha un suono – e non solo uno – che le corrisponde, non crederei nemmeno ai miei occhi nello specchio. E alla voce degli esseri umani.
È l’effetto Power Play, trent’anni dopo. Mica poco.
VI
La resurrezione di Glenn Hughes
Nel 1993 cercavo, senza molto successo, di fare il rappresentante di libri porta a porta. La mia percentuale era del dieci per cento, ma in quattro mesi di lavoro avevo incassato pochissimo. Molte porte in faccia, un paio di alterchi e l’inseguimento a opera di un cane inferocito.
Però sentivo che le cose mi giravano. Quando pensavo alla mia età, ventun anni, mi sentivo un leone.
I pochi proventi ottenuti dalle mie improvvisate vendite porta a porta li usavo per viaggi spartani, improntati alla più totale disorganizzazione mentale e spirituale, per il vizio del fumo e quello, più impegnativo, dei dischi.
Una sera – era un giorno d’inverno – mi telefonò un amico di vecchio corso, un altro fissato con la musica, appassionato come me di Deep Purple e qualsiasi cosa fosse affine alla grande band. Il classico concetto molto anglosassone di “band and relatives”. Così Piero mi annunciò con grande enfasi che il leggendario bassista e cantante Glenn Hughes – che, ci tengo a precisarlo, fu con i Deep Purple solo in tre altrettanto leggendari album virati a una celestiale e inedita commistione tra hard rock e funk – era tornato a incidere in veste di solista.
«Dopo essere stato per molti anni nei labirinti e nei materassi della cocaina, Glenn è tornato...»
«Materassi?»
«Sì, si dice, no? Si dice anche materassi... l’ho sentito dire a una persona.»
«Ed è per questo che si dice?»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.