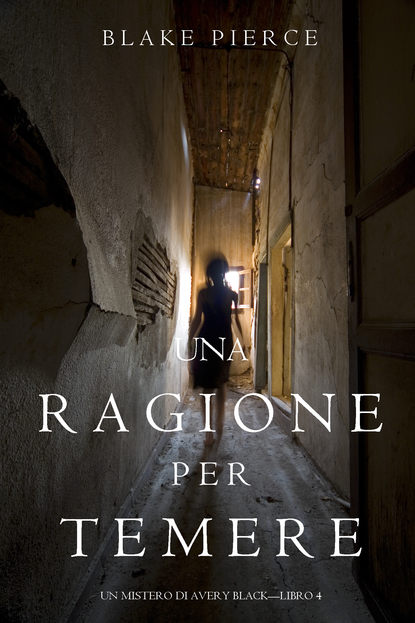Una Ragione per Uccidere

- -
- 100%
- +
“Bell’auto,” scherzò Avery.
“Questa bellezza mi ha salvato moltissime volte,” raccontò lui orgoglioso mentre accarezzava con affetto il cofano. “Basta che mi vesta da pappone o da ispanico morto di fame e nessuno si accorge di me.”
Uscirono dal parcheggio.
Il Lederman Park era a pochi chilometri dalla stazione di polizia. Procedettero verso ovest su Cambridge Street e voltarono a destra sulla Blossom.
“Quindi,” disse Ramirez, “ho sentito che una volta eri avvocato.”
“Sì?” Cauti occhi blu gli lanciarono uno sguardo di sbieco. “Che altro hai sentito?”
“Avvocato difensore,” continuò lui, “il meglio del meglio. Hai lavorato alla Goldfinch & Seymour. Non robetta. Perché hai smesso?”
“Non lo sai?”
“So che hai difeso un sacco di criminali. Una carriera perfetta, giusto? Hai persino messo dietro le sbarre qualche poliziotto corrotto. Deve essere stata una bella vita. Ottimo stipendio, una serie di successi. Che razza di persona si lascia tutto questo alle spalle per entrare in polizia?”
Avery ripensò alla casa in cui era cresciuta, una piccola fattoria circondata per miglia da terreni pianeggianti. La solitudine non le era mai andata a genio. E neppure gli animali o l’odore di quel posto: feci e pelliccia e piume. Aveva voluto andarsene fin dall’inizio. Lo aveva fatto: Boston. Prima l’università e poi la facoltà di legge e la carriera.
E ora quello.
Le sfuggì un sospiro dalle labbra.
“Immagino che a volte le cose non vadano come abbiamo progettato.”
“Che cosa vorresti dire?”
Nella sua mente vide di nuovo quel sorriso, il sorriso antico e sinistro del vecchio rugoso dagli occhiali spessi. All’inizio era sembrato tanto sincero, così umile e intelligente e onesto. Tutti lo sembravano, pensò.
Fino a quando i processi non si concludevano e loro tornavano alle vite di tutti i giorni, e lei era costretta ad accettare di non essere la salvatrice degli indifesi, la paladina degli oppressi, ma una pedina, una semplice pedina in un gioco troppo complesso e dalle radici troppo profonde per essere cambiato.
“La vita è dura,” affermò lei. “Un giorno pensi di sapere qualcosa e quello seguente, si solleva il velo e tutto cambia.”
Lui annuì.
“Howard Randall,” disse, comprendendo.
Quel nome la rese più consapevole di tutto, l’aria fresca nell’auto, la sua posizione sul sedile, dove si trovavano in città. Nessuno aveva più pronunciato il suo nome da molto tempo, specialmente a lei. Si sentì esposta e vulnerabile, e per reazione irrigidì i muscoli e si sedette più diritta.
“Mi dispiace,” disse lui, “non volevo…”
“Va tutto bene.”
Solo che non andava bene. Dopo di lui era finito tutto. La sua vita. Il suo lavoro. La sua sanità mentale. Il lavoro come avvocato penale era duro, per usare un eufemismo, ma lui avrebbe dovuto mettere tutto a posto. Un geniale professore di Harvard, rispettato da tutti, modesto e gentile, era stato accusato di omicidio. La redenzione di Avery sarebbe dovuta arrivare grazie alla sua difesa. Per una volta, avrebbe potuto fare ciò che aveva sognato sin dall’infanzia: difendere gli innocenti e assicurarsi che la giustizia prevalesse.
Ma non era successo niente del genere.
CAPITOLO TRE
Il parco era già stato chiuso al pubblico.
Due agenti in borghese bloccarono l’auto di Ramirez, fecero loro cenno di allontanarsi dal parcheggio principale e di andare a sinistra. Tra i poliziotti che erano chiaramente membri del suo dipartimento, Avery notò un certo numero di agenti statali.
“Perché c’è la cavalleria?” chiese.
“Il loro quartier generale è proprio in fondo alla strada.”
Ramirez fermò l’auto e parcheggiò vicino a una fila di volanti della polizia. Il nastro giallo aveva già isolato un’ampia area del parcheggio. Furgoni dei notiziari, giornalisti, telecamere e un gruppetto di sportivi e altri frequentatori abituali del parco erano assiepati vicino al nastro, cercando di vedere che cosa stava succedendo.
“Oltre questo punto non potete avanzare,” disse un poliziotto.
Avery gli mostrò il distintivo.
“Omicidi,” disse. Era la prima volta che pronunciava ad alta voce la sua nuova posizione, e la riempì di gioia.
“Dove è Connelly?” chiese Ramirez.
Un agente indicò tra gli alberi.
Si avviarono sull’erba, a sinistra di un diamante da baseball. Oltre la linea degli alberi furono accolti da altro nastro giallo. Sotto il fitto fogliame c’era un sentiero che si estendeva lungo il fiume Charles. Un solo agente, insieme a uno specialista della scientifica e a un fotografo, era immobile davanti a una panchina.
Avery evitò il contatto iniziale con chi era già sulla scena. Nel corso degli anni aveva scoperto che le interazioni sociali la deconcentravano, e troppo domande e formalità con gli altri inquinavano il suo punto di vista. Purtroppo era un’altra delle sue caratteristiche che le aveva meritato il disprezzo dell’intero dipartimento.
La vittima era una ragazza giovane, appoggiata di traverso sulla panchina. Era chiaramente morta, ma ad eccezione del tono bluastro della pelle, la sua posizione e l’espressione del suo volto avrebbero potuto ingannare un comune passante, prima che si accorgesse che c’era qualcosa che non andava.
Come una ragazza in attesa dell’innamorato, aveva le mani posate sullo schienale della panchina. Su di esse era appoggiato il suo mento. Un sorriso malizioso le incurvava le labbra. Il corpo era voltato, come se fosse stata seduta e si fosse spostata per guardare qualcuno o per fare un profondo respiro. Indossava un abito estivo giallo e infradito bianche, e i bei capelli ramati le ricadevano sulla spalla sinistra. Le sue gambe erano incrociate e le dita dei piedi erano posate delicatamente sul sentiero.
Solo gli occhi della vittima rivelavano il suo tormento. Trasmettevano dolore e incredulità.
Avery sentì una voce nella mente, la voce di un uomo anziano che perseguitava le sue notti e i suoi sogni a occhi aperti. Parlando delle sue vittime, una volte le aveva chiesto: Che cosa sono? Solo contenitori, contenitori senza volto e senza nome, così pochi tra miliardi, in attesa di trovare il loro scopo.
La rabbia le salì nel petto, rabbia per essere stata esposta e umiliata e soprattutto, per la sua vita mandata in frantumi.
Si avvicinò al corpo.
In qualità di avvocato, era stata costretta a esaminare un numero infinito di rapporti della scientifica, foto del coroner e qualsiasi altra cosa avesse a che vedere con il caso. Da poliziotta, le sue conoscenze era notevolmente aumentate, dato che analizzava di persona e quotidianamente le vittime di omicidi, e riusciva a dare valutazioni più oggettive.
Notò che il vestito era stato pulito, e i capelli della vittima erano stati lavati. Sulle unghie dei piedi e delle mani erano stato dato lo smalto di recente, e quando annusò intentamente la sua pelle, sentì l’odore del cocco e di miele, e solo un leggero sentore di formaldeide.
“Hai intenzione di baciarla?” chiese qualcuno.
Avery era china sul corpo della vittima, con le mani dietro la schiena. Sulla panchina c’era un cartellino giallo con il numero ‘4’. Accanto, in grembo alla ragazza, c’era un rigido pelo arancione, a malapena visibile sul giallo dell’abito.
Il supervisore della Omicidi Dylan Connelly era fermo con le mani sui fianchi, in attesa di una risposta. Era un uomo duro e vigoroso, con capelli biondi e mossi e penetranti occhi blu. Il suo petto e le braccia sembravano sul punto di esplodere dalla camicia azzurra. Indossava pantaloni di lino marrone, e grossi stivali neri gli coprivano i piedi. Avery lo aveva notato spesso in ufficio; non era esattamente il suo tipo, ma in lui c’era una ferocia animale che ammirava.
“Questa è la scena di un crimine, Black. La prossima volta guarda dove vai. Sei fortunata che abbiamo già rilevato le impronte e le orme.”
Lei abbassò lo sguardo, sorpresa; era stata attenta a dove metteva i piedi. Lo guardò negli occhi color ghiaccio e si rese conto che stava solo cercando una scusa per rimproverarla.
“Non sapevo che fosse una scena del crimine,” rispose lei. “Grazie per l’informazione.”
Ramirez ridacchiò.
Connelly digrignò i denti e fece un passo in avanti.
“Sai perché nessuno ti sopporta, Black? Non è perché sei un’estranea, è che quando eri là fuori, non avevi alcun rispetto per la polizia, e ora che sei dentro ne hai ancora di meno. Fammi mettere le cose in chiaro: tu non mi piaci, non mi fido di te, e di certo non ti voglio nella mia squadra.”
Si voltò verso Ramirez.
“Dille quello che sappiamo. Io vado a casa a farmi una doccia. Mi viene da vomitare,” disse. Si tolse i guanti e li gettò a terra. Rivolto ad Avery, aggiunse: “Mi aspetto un rapporto completo per la fine della giornata. Alle cinque in punto. Nella sala conferenze. Mi hai capito? Non fare tardi. E accertati di ripulire questo casino, prima di andartene. La polizia di stato è stata tanto gentile da lasciarci lavorare. Tu sii gentile e mostra loro la stessa cortesia.”
Irritato, Connelly se ne andò.
“Tu sì che ci sai fare con la gente,” commentò ammirato Ramirez.
Avery scrollò le spalle.
La specialista forense sulla scena era una giovane afro-americano formosa di nome Randy Johnson. Aveva occhi grandi e un atteggiamento disinvolto. Era bassa, e i capelli intrecciati erano nascosti solo parzialmente sotto il berretto bianco.
Avery aveva già lavorato insieme a lei. Durante un caso di violenza domestica avevano legato molto. L’ultima volta che si erano viste era stato davanti a un drink.
Felice di lavorare su un altro caso insieme ad Avery, Randy le tese una mano, notò il proprio guanto, arrossì, ridacchiò e disse: “Ops,” seguito da una buffa espressione disgustata e la proclamazione: “Potrei essere contaminata.”
“Anche per me è bello vederti, Randy.”
“Congratulazioni per essere entrata alla Omicidi,” Randy si inchinò. “Ti stai facendo strada nel mondo.”
“Uno psicopatico alla volta. Che cosa abbiamo?”
“Direi che qualcuno era innamorato,” rispose Randy. “È stata ripulita per bene. L’hanno aperta dalla schiena. Le hanno svuotato il corpo, l’hanno riempito perché non marcisse, e ricucito. Vestiti puliti. Manicure. Sono stati anche attenti, ancora niente impronte digitali. Non molto su cui lavorare fino a quando non arriverò in laboratorio. Riesco a vedere solo due ferite. Vedi la bocca? Per far sorridere così un cadavere la puoi fissare dall’interno, o usare del gel. Dalla puntura che c’è qui,“ indicò l’angolo della bocca, “direi una puntura. Ce n’è un’altra qui,” notò sul collo. “A giudicare dalla colorazione, questo è successo prima, forse al momento del rapimento. È morta da circa quarantotto ore. Ho trovato un paio di peli interessanti.”
“Da quanto tempo è qui?”
“Dei ciclisti l’hanno trovata alle sei,” disse Ramirez. “Il parco viene pattugliato tutte le notti, su mezzanotte e sulle tre. Non hanno visto niente.”
Avery non riusciva a smettere di fissare gli occhi della ragazza morta. Sembravano guardare qualcosa in lontananza e tuttavia vicino alla battigia, sul loro lato del fiume. Si spostò con attenzione dietro la panchina e cercò di seguire la sua traiettoria visiva. A valle c’erano diversi edifici bassi di mattoni, uno era largo e in cima aveva una cupola bianca.
“Che posto è quello?” chiese. “Quello largo con la cupola?”
Ramirez strizzò gli occhi.
“Forse l’Omni Theatre?”
“Possiamo sapere che cosa stanno dando?”
“Perché?”
“Non lo so, è solo un’idea.”
Avery si alzò.
“Sappiamo chi è?”
“Sì,” rispose Ramirez e controllò i suoi appunti. “Pensiamo che si chiami Cindy Jenkins. Fa l’ultimo anno ad Harvard. Membro di una sorellanza, la Kappa Kappa Gamma. È sparita due notti fa. La polizia del campus e di Cambridge ha fatto circolare la sua foto, la notte scorsa. Connelly ha fatto fare un controllo e la sua combacia. Ci serve ancora la conferma. Chiamerò la famiglia.”
“E per quel che riguarda i video di sorveglianza?”
“Jones e Thompson se ne stanno occupando. Li conosci, giusto? Ottimi detective. Per oggi sono assegnati a noi. Dopo di che siamo da soli a meno che non possiamo dimostrare che ci servono più risorse. All’entrata del parco non ci sono telecamere, ma ce n’è qualcuna sulla superstrada e dall’altra parte della strada. Dovremmo sapere qualcosa questo pomeriggio.”
“Ci sono testimoni?”
“Finora nessuno. I ciclisti sono puliti. Posso chiedere in giro.”
Avery studiò l’area circostante. Il nastro giallo racchiudeva un’ampia parte del parco. Vicino al fiume, sul sentiero delle bici o sull’erba non era stato trovato niente di fuori dall’ordinario. Cercò di formarsi un’immagine mentale degli eventi. Sarebbe dovuto arrivare in auto sulla strada principale e parcheggiare vicino all’acqua, per avere facile accesso alla panchina. Come aveva fatto a portare il corpo fino alla panchina senza destare sospetti?
Rifletté. Era possibile che qualcuno lo vedesse. Si doveva essere preparato per quell’eventualità. Forse aveva fatto finta che fosse viva? Avery si rigirò verso il corpo. Certo era una possibilità. La ragazza era bellissima, anche nella morte, quasi eterea. Doveva aver impiegato molto tempo e pianificazione per assicurarsi che sembrasse perfetta. Non era l’uccisione di una banda, si rese conto. Non era un amante deluso. Era diverso. Avery lo aveva già visto prima.
All’improvviso si chiese se O’Malley non avesse avuto ragione. Forse non era pronta.
“Posso prendere in prestito la tua auto?” chiese.
Ramirez inarcò un sopracciglio.
“E la scena del crimine?”
Lei si scrollò decisa.
“Sei grande e vaccinato. Fai tu.”
“E tu dove vai?”
“Ad Harvard.”
CAPITOLO QUATTRO
Era seduto nell’ufficio dentro il cubicolo, superiore, vittorioso, più potente di chiunque altro sul pianeta. Lo schermo di un computer era acceso davanti a lui. Con un respiro profondo, chiuse gli occhi, e ricordò.
Richiamò alla mente il cavernoso scantinato di casa sua, più che altro un vivaio. Nella stanza principale erano allineate diverse varietà di fiori di papavero: rossi, gialli e bianchi. Molte altre piante psichedeliche, ognuna trovata nel corso di anni, erano sistemate dentro lunghe mangiatoie; alcune erano erbe dall’aspetto alieno o dei fiori interessanti; molte avevano un’aria comune che sarebbe stata ignorata in mezzo ad altre erbe selvatiche, nonostante le loro potenziali capacità. Un sistema di irrigazione a tempo, un termometro e luci LED le mantenevano rigogliose.
Un lungo corridoio rivestito di travi di legno portava alle altre stanze. Sulle pareti c’erano delle foto. La maggior parte erano di animali in varie fasi della morte e poi della ‘rinascita’, nella quale erano stati impagliati e messi in posizione: un gatto soriano sollevato sulle zampe posteriori a giocare con la lana, un cane a macchie bianche e nere, sdraiato sulla schiena in attesa di carezze sulla pancia. Poi arrivò alle porte. Immaginò che quella a sinistra fosse aperta. Dentro, la vide di nuovo, il suo corpo nudo steso sul tavolo argentato. Intense luci fluorescenti illuminavano lo spazio. In un scatola di vetro c'erano diversi liquidi colorati dentro barattoli trasparenti.
Quando le aveva strofinato le dita lungo l’esterno della coscia, aveva sentito la sua pelle. Mentalmente ripeté ogni delicata procedura: svuotare, preservare, pulire e impagliare il suo corpo. Durante la sua rinascita aveva scattato delle foto che in seguito sarebbero state appese su altre pareti destinate ai suoi trofei umani. Alcune delle foto erano già state sistemate.
Un'energia straordinaria e surreale fluiva dentro di lui.
Per anni aveva evitato gli essere umani. Facevano paura, più violenti e incontrollabili degli animali. Amava gli animali. Tuttavia aveva scoperto che gli umani erano dei sacrifici più potenti per lo Spirito Universale. Dopo la morte della ragazza aveva visto il cielo aprirsi e l'immagine indistinta del Grande Creatore lo aveva guardato e gli aveva detto: Ancora.
I suoi sogni a occhi aperti furono interrotti da una voce brusca.
“Hai di nuovo con la testa tra le nuvole?”
Un impiegato irritato incombé su di lui con un cipiglio sul volto. Aveva la faccia e il corpo di un ex giocatore di football. L'abito azzurro faceva ben poco per mitigare la sua ferocia.
Timidamente, abbassò la testa. Incurvò leggermente le spalle, e si trasformò in un impiegato banale e insignificante.
“Mi dispiace, signor Peet.”
“Sono stanco delle tue scuse. Dammi quei dati.”
Dentro di sé l'assassino sorrise come un gigante divertito. A lavoro il gioco era eccitante quasi quanto nella vita privata. Nessuno sapeva quando fosse speciale, quanto fosse devoto ed essenziale al delicato equilibrio dell'universo. Nessuno di loro avrebbe ricevuto un posto d'onore nel reame del Mondo di Sopra. Le loro mansioni quotidiane, banali, terrene: vestirsi, incontrarsi, spingere denaro da una parte all'altra, erano tutte prive di senso; per lui lo avevano solo perché lo collegava al mondo esterno e gli permettevano di fare il lavoro del Signore.
Il suo boss brontolò e si allontanò.
A occhio chiusi, il killer immaginò il suo Alto Signore, la figura oscura e indistinta che sussurrava nei suoi sogni e dava una direzione ai suoi pensieri.
Sulle sue labbra prese forma un canto in segno di omaggio, e sussurrò: “Oh, Signore, oh Signore, il nostro lavoro è puro. Chiedi e io ti darò: Ancora.”
Ancora.
CAPITOLO CINQUE
Avery aveva un nome: Cindy Jenkins. Conosceva la sorellanza, la Kappa Kappa Gamma. E aveva molta familiarità con l'Università di Harvard. La prestigiosa scuola l'aveva rifiutata il suo primo anno, ma lei aveva ugualmente trovato un modo per godersi la vita a Harvard durante la sua carriera al college, uscendo con due ragazzi che la frequentavano.
A differenza degli altri college, le sorellanze di Harvard non erano riconosciute ufficialmente. Non esistevano case delle sorellanze, all’interno o fuori dal campus. Invece le feste si tenevano regolarmente in diversi appartamenti esterni al campus o in complessi residenziali sotto il nome di ‘organizzazioni’ o ‘club’ specializzati. Avery stessa era stata testimone del paradosso della vita al college durante la sua carriera accademica. Tutti fingevano di essere concentrati unicamente sui voti, fino a quando non tramontava il sole e si trasformavano in un branco di scatenati animali da festa.
A un semaforo rosso, Avery fece una rapida ricerca online e scopri che la Kappa Kappa Gamma affittava due spazi nello stesso quartiere di Cambridge: Church Street. Uno degli spazi era per gli eventi e l'altro per le riunioni e per socializzare.
Attraversò il Longfellow Bridge, oltre il MIT, e svoltò a destra sulla Massachusetts Avenue. Alla sua destra apparve l’Harvard Yard, con i suoi magnifici palazzi di mattoni rossi incastonati in una foresta di alberi e sentieri pavimentati.
Trovò parcheggio su Church Street.
Avery lasciò l'auto, chiuse la portiera e sollevò il volto verso il sole. Era una giornata calda, con temperature che raggiungevano quasi i trenta gradi.
Il palazzo della Kappa era una lunga struttura a due piani con una facciata di mattoni. Il primo piano ospitava un gran numero di negozi di vestiti. Avery immaginò che il secondo piano fosse riservato agli uffici e alle attività della sorellanza. Accanto al campanello del secondo piano l'unico simbolo era un giglio blu, simbolo di Harvard; lo premette.
Una roca voce femminile si alzò dal sistema di interfono.
“Sì?”
“Polizia,” disse a denti stretti, “aprite.”
Silenzio per un momento.
“Davvero,” rispose la voce, “chi è?”
“È la polizia,” ripeté con fermezza. “Va tutto bene. Nessuno è nei guai. Ho solo bisogno di parlare con qualcuno della Kappa Kappa Gamma.”
La porta fu aperta.
In cima alle scale, Avery venne accolta da una ragazza stanca e assonnata in una maglietta grigia troppo grande per lei e pantaloni della tuta bianchi. Mora, sembrava una festaiola. Ciuffi di capelli le nascondevano la maggior parte del volto. Attorno agli occhi aveva cerchi scuri, e il fisico che normalmente sottolineava con tanto orgoglio sembrava grosso e senza forma.
“Che cosa vuole?” chiese.
“Calma,” rispose Avery. “Non ha niente a che fare con le attività della sorellanza. Sono qui solo per fare qualche domanda.”
“Posso vedere un documento di identificazione?”
Avery le mostrò il distintivo.
La ragazza squadrò Avery da capo a piedi, studiò il distintivo e fece un passo indietro.
L’area della Kappa Kappa Gamma era ampia e luminosa. Il soffitto era alto. Un gran numero di comodi divani in pelle e pouf blu riempivano l'area. Le pareti erano state dipinte di blu scuro. C'era un bar, un impianto stereo e un’enorme TV a schermo piatto. Le finestre erano alte quasi fino al soffitto. Dall'altra parte della strada, Avery poteva vedere la cima di un altro basso complesso di appartamenti, e poi il cielo. Qualche nuvola attraversò pigramente il cielo.
Immaginò che la sua esperienza al college fosse stata molto diversa da quella della maggior parte delle ragazze nella Kappa Kappa Gamma. Tanto per cominciare, si era pagata la scuola da sola. Ogni giorno dopo le lezioni era andata in uno studio legale locale e aveva fatto carriera, da segretaria a celebrata paralegale. Inoltre a scuola aveva bevuto molto raramente. Suo padre era stato un violento alcolizzato. Durante la maggior parte delle serate era stata l'autista designato o nel dormitorio a studiare.
Un’espressione di speranza illuminò il volto della ragazza.
“Si tratta di Cindy?” chiese.
“Cindy è una tua amica?”
“Sì, la mia migliore amica,” rispose. “Per favore, mi dica che sta bene?”
“Come ti chiami?”
“Rachel Strauss.”
“Sei tu che hai chiamato la polizia?”
“Esatto. Cindy se ne è andata ubriaca dalla nostra festa di sabato notte. Da allora non l'ha più vista nessuno. Non è da lei.” Alzò gli occhi al cielo e fece un sorrisetto, aggiungendo: “Di solito è molto prevedibile. È tipo, miss perfettina, capisce? Sempre a letto alla stessa ora, stesso programma che non cambia mai, le serve un preavviso di circa cinque anni per qualsiasi novità. Sabato era fuori di testa. Ha bevuto. Ha ballato. Per un po' ha gettato via l'orologio. È stato un bello spettacolo.”
Per un momento Rachel si perse a guardare nel vuoto.
“Era solo molto felice, sa?”
“Qualche motivo in particolare?" chiese Avery.
“Non so, è la migliore della classe. Deve iniziare a lavorare questo autunno.”
“Che lavoro?”
“Alla Devante? Sono, ecco, lo studio migliore di Boston. È specializzanda in contabilità. È così noioso, lo so, ma in fatto di numeri è un genio.”
“Mi puoi raccontare di sabato notte?”
Gli occhi di Rachel si riempirono di lacrime.
“Si tratta davvero di Cindy, non è vero?”
“Sì,” ripose Avery. “Magari possiamo sederci?”
Rachel crollò sul divano e scoppiò a piangere.
Tra i singhiozzi cercò di parlare.
“Sta bene? Dov’è?”
Era la parte del lavoro che Avery odiava di più, dover parlare con gli amici e i parenti. Aveva il permesso di dare solo alcune informazioni. Più dettagli la gente sapeva a proposito di un caso, e più ne parlava, e quelle parole riuscivano inevitabilmente ad arrivare ai responsabili del crimine. Nessuno lo capiva né se ne curava sul momento, erano troppi sconvolti. Tutto ciò che volevano erano delle risposte.
Avery si sedette accanto a lei.
“Siamo molto felici che tu abbia chiamato,” disse. “Hai fatto la cosa giusta. Temo di non poter parlare di un'indagine in corso, ma quello che posso dirti è che sto facendo tutto ciò che è in mio potere per scoprire che cosa è successo a Cindy quella notte. Non posso farcela da sola, ho bisogno del tuo aiuto.”
Rachel annuì e si asciugò gli occhi.
“Posso aiutarla,” disse, “posso aiutarla.”