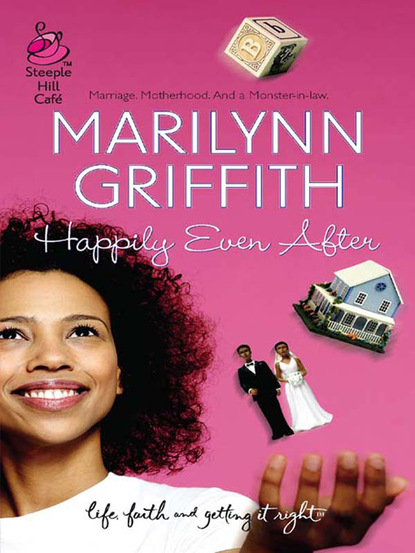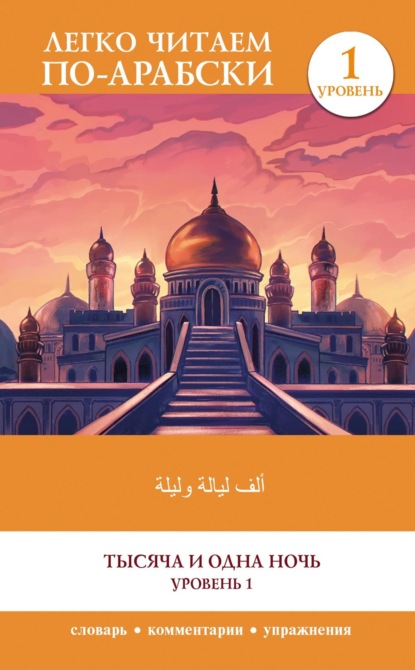Un Mare Di Scudi

- -
- 100%
- +
Il bere raggiunse il suo picco e altri boccali vennero fatti passare tra la gente, il doppio di prima, e i McCloud non si arrestavano come generalmente i soldati facevano giunti a quel punto. Bevevano invece addirittura di più, addirittura troppo. Godfrey stava iniziando a sentirsi nervoso.
“Pensi che un uomo possa mai bere così tanto?” chiese Godfrey ad Akorth.
Akorth ridacchiò.
“Domanda sacrilega!” disse con superficialità.
“Cosa ti prende?” chiese Fulton.
Ma Godfrey era molto attento mentre un McCloud, ubriaco a tal punto, andò ad inciampare contro dei compagni facendoli cadere a terra.
Per un secondo ci fu una pausa e tutti si voltarono a guardare il gruppo di soldati al suolo.
Ma poi i soldati balzarono di nuovo in piedi, gridando e ridendo, esultando e – con sollievo di Godfrey – i festeggiamenti proseguirono.
“Direste che ne hanno avuto abbastanza?” chiese Godfrey iniziando a domandarsi se quella fosse stata una cattiva idea.
Akorth lo guardò con occhi vacui.
“Abbastanza?” chiese. “Esiste una cosa del genere?”
Godfrey notò che anche lui biascicava mentre parlava e che la sua mente non era pronta e reattiva come avrebbe voluto. Eppure iniziava a percepire che qualcosa stava cambiando nella stanza, come se le cose non stessero andando come avrebbero dovuto. Era tutto un po’ troppo, come se la gente là dentro avesse in parte perso il senso del controllo.
“Non toccarla!” gridò improvvisamente qualcuno. “È mia!”
Il tono di quella voce era cupo, pericoloso, e squarciò l’aria facendo voltare Godfrey.
Dalla parte opposta della sala un MacGil si alzò in piedi, con il petto in fuori, litigando con un McCloud. Il McCloud aveva afferrato e tirato a sé una donna che sedeva in grembo al MacGil.
“Era tua! Adesso è mia! Va’ a trovartene un’altra!
L’espressione del MacGil si fece più cupa e l’uomo sguainò la spada. Il caratteristico suono metallico risuonò nella stanza e tutti si voltarono.
“Ho detto che è mia!” gridò.
Aveva il volto rosso, i capelli impiastricciati di sudore e tutti nella stanza guardavano la scena attirati da quel tono truce.
Tutto si fermò improvvisamente e calò il silenzio mentre entrambe le parti osservavano immobili. Il McCloud, un uomo grosso e nerboruto guardò l’avversario con sguardo torvo, prese la donna e la scagliò con impeto dalla parte opposta. La malcapitata volò tra la folla, inciampando e cadendo a terra.
Al McCloud chiaramente non interessava della donna, ora era ovvio che lo spargimento di sangue era ciò che desiderava veramente.
Il McCloud sguainò la spada e si preparò all’attacco.
“Dovrai passare sul mio corpo per averla!” disse.
I soldati da entrambe le parti si allargarono, facendo spazio perché i due potessero combattere. Godfrey notò che tutti erano tesi. Sapeva che doveva fermare tutto prima che si trasformasse in una guerra vera e propria.
Godfrey saltò sul tavolo, scivolando tra boccali di birra, si fece strada attraversando al sala e corse dove si trovavano i due contendenti allargando le braccia per tenerli a bada.
“Uomini!” gridò con voce biascicante. Cercava di rimanere concentrato e di costringere la sua mente a pensare chiaramente. Si pentì sinceramente di aver bevuto così tanto.
“Siamo tutti uomini qui!” gridò. “Siamo tutti un unico popolo! Un esercito! Non c’è bisogno di un duello! Ci sono un sacco di donne in giro. Nessuno di voi voleva fare un torto all’altro!”
Godfrey si voltò verso il MacGil che stava lì fermo, torvo, con la spada in mano.
“Se mi porgerà le sue scuse, le accetterò,” disse il MacGil.
Il McCloud rimase fermo, confuso. Poi improvvisamente la sua espressione si ammorbidì e sorrise.
“E allora mi scuso!” gridò, porgendo la mano sinistra.
Godfrey si fece da parte e il MacGil prese la mano in modo incerto.
Ma quando lo fece, il McCloud strinse e tirò l’uomo verso di sé, sollevò la spada e lo trafisse dritto al petto.
“Mi scuso,” aggiunse, “per non averti ucciso prima! Schifoso MacGil!”
Il soldato cadde al suolo, floscio, tra il sangue che si riversava ovunque sul pavimento.
Morto.
Godfrey rimase fermo e scioccato. Era a neanche un metro dal soldato e non poteva evitare di sentirsi come se fosse in parte colpa sua. Lui aveva incoraggiato il MacGil ad abbassare la guardia. Lui aveva cercato di negoziare la tregua. Lui stesso era stato tradito da quel McCloud che si era preso gioco di lui di fronte a tutti i suoi uomini.
Godfrey non era in grado di pensare chiaramente e, caricato dal bere, qualcosa dentro di lui si spezzò.
In un unico movimento si chinò a terra, prese la spada del MacGil morto, fece un passo avanti e colpì il McCloud al cuore.
Il McCloud lo guardò con gli occhi sgranati, poi si accasciò al suolo, morto, la spada ancora conficcata nel petto.
Godfrey abbassò lo sguardo sulla propria mano insanguinata non riuscendo a credere a ciò che aveva appena fatto. Era la prima volta che uccideva un uomo in un confronto corpo a corpo. Non sapeva di poterne essere capace.
Non aveva programmato di ucciderlo, non ci aveva neppure pensato. Era stata una parte nascosta di sé che lo aveva sopraffatto, una parte che aveva richiesto vendetta per quell’ingiustizia.
Subito esplose il caos nella stanza. Da tutte le parti gli uomini iniziarono a gridare e attaccare, furiosi. Presto il rumore delle spade riempì la stanza e Godfrey stesso si sentì spingere con forza da Akorth, proprio un attimo prima che una spada lo colpisse alla testa.
Un altro soldato – Godfrey non ricordava chi o perché – lo afferrò e lo gettò oltre il tavolo e l’ultima cosa che Godfrey ricordò fu di scivolare lungo il tavolo colpendo ogni boccale di birra fino ad atterrare al suolo sbattendo la testa e desiderando di trovarsi in qualsiasi altro posto purché non lì.
CAPITOLO SEI
Gwendolyn, in sedia a rotelle, Guwayne in braccio, si teneva pronta mentre i servitori aprivano le porte e Thor la spingeva nella stanza della madre malata. Le guardie della regina chinarono la testa e si fecero da parte e Gwen strinse più forte il bambino mentre accedevano alla buia camera. La stanza era silenziosa, soffocante, senza aria. Le torce baluginavano cupamente su tutte le pareti. Si percepiva la morte nell’aria.
Guwayne, pensò. Guwayne. Guwayne.
Ripeté silenziosamente il nome nella propria mente, cercando di concentrarsi su qualsiasi altra cosa ma non sulla madre morente. Mentre ci pensava, il nome del bimbo le portò conforto e la riempì di calore. Guwayne. Il bambino del miracolo. Amava quel bimbo più di quanto potesse dire.
Gwen voleva che sua madre lo vedesse prima di morire. Voleva che sua madre fosse orgogliosa di lei, voleva la sua benedizione. Doveva ammetterlo: nonostante il loro passato difficile, Gwen voleva la pace e la risoluzione nel loro rapporto prima che lei morisse. Ora di trovava lei stessa in uno stato fragile e il fatto di essersi affezionata di più a sua madre nelle scorse lune la faceva sentire ora ancora più sconvolta.
Si sentì stringere il cuore quando le porte si chiusero alle sue spalle. Si guardò attorno nella stanza e vide una decina di servitori che si trovavano al capezzale della madre: uomini della vecchia guardia che lei stessa conosceva e che erano soliti sorvegliare suo padre. La stanza era piena di gente. Era una veglia funebre. Al fianco di sua madre ovviamente si trovava Hafold, la servitrice fedele fino alla morte, che la vegliava senza permettere a nessuno di avvicinarsi troppo, come aveva fatto per tutta la vita.
Quando Thor spinse Gwendolyn accanto al letto di sua madre, Gwen avrebbe voluto alzarsi in piedi, chinarsi su sua madre, abbracciarla. Ma il suo corpo le doleva ancora e in quella condizione non riuscì a fare nulla di ciò che desiderava.
Allungò invece una mano e prese il polso di sua madre. era freddo.
In quel momento sua madre, stesa lì priva di conoscenza, aprì lentamente un occhio. La guardò sorpresa e compiaciuta al vederla. Poi aprì entrambi gli occhi e aprì anche la bocca per parlare.
Fece per pronunciare delle parole, ma emise solo dei sospiri. Gwen non riuscì a capirla.
Sua madre si schiarì la gola e fece un cenno verso Hafold.
Hafold si chinò immediatamente verso di lei, porgendo l’orecchio verso la bocca della regina.
“Sì, mia signora?” chiese.
“Manda tutti fuori. Voglio stare sola con mia figlia e Thorgrin.”
Hafold diede una rapida occhiata a Gwen, risentita, poi rispose: “Come desiderate, mia signora.”
Hafold fece immediatamente cenno a tutti di uscire velocemente dalla porta, poi tornò al capezzale e si riprese posto accanto alla regina.
“Da sola,” le ripeté la regina con sguardo fermo.
Hafold abbassò gli occhi sorpresa, poi guardò Gwen con gelosia e uscì un fretta e furia dalla stanza, chiedendo con fermezza la porta alle proprie spalle.
Gwen rimase lì con Thor, sollevata dal fatto che tutti se ne fossero andati. Nell’aria era sospesa una pesante coltre di morte. Gwendolyn la percepiva, sapeva che sua madre non sarebbe rimasta a lungo con lei.
Sua madre le strinse la mano e Gwen ricambiò la stretta. La regina sorrise e una lacrima le scivolò lungo la guancia.
“Sono felice di vederti,” le disse. Le parole uscirono come un sussurro, appena udibili.
Gwen ebbe ancora voglia di piangere, ma cercò di essere forte e di trattenere la lacrime per il bene di sua madre. eppure non poté fare molto: le lacrime iniziarono improvvisamente a scendere e lei scoppiò a piangere.
“Madre,” disse. “Mi spiace. Mi spiace così tanto. Per tutto.”
Gwen si sentì assalita dal dolore per non esserle stata più vicina in vita. Le due non si erano mai pienamente comprese. Le loro personalità si erano sempre scontrate e non erano mai riuscite a vedere le cose allo stesso modo. Gwen era dispiaciuta per la loro relazione, anche se non si biasimava per questo. Avrebbe voluto, guardando indietro, aver potuto dire o fare qualcosa per cambiare le cose. Ma erano semplicemente state da due parti diverse in ogni cosa nella loro vita. E sembrava che nessuno sforzo da nessuna delle due parti avrebbe mai potuto cambiare nulla. Erano solo due esseri umani molto diversi, incastrate nella medesima famiglia, incastrate in una difficile relazione madre-figlia. Gwen non era mai stata la figlia che lei aveva voluto e la regina non era mai stata la madre che Gwen avrebbe desiderato. Gwen si era chiesta più volte perché fossero state destinate a stare insieme.
La regina annuì e Gwen vide che capiva.
“Sono io che mi scuso,” le rispose. “Sei una figlia straordinaria. E una regina straordinaria. Una regina molto migliore di quella che sono stata io. E una sovrana molto migliore di quanto sia stato tuo padre. Ne sarebbe orgoglioso. Ti saresti meritata una madre migliore di me.”
Gwen cacciò indietro le lacrime.
“Sei stata una brava madre.”
La regina scosse la testa.
“Sono stata una brava regina. Una moglie devota. Ma non sono stata una brava madre. Non per te, almeno. Credo di aver visto molto di me stessa in te, e questo mi ha spaventata.”
Gwen le strinse la mano, piangendo, desiderando di poter avere più tempo da trascorrere con lei, desiderando di aver potuto parlare a quel modo molto tempo prima. Ora che era regina, ora che il tempo era passato per entrambe, ora che lei aveva un bambino, Gwen voleva sua madre lì. Voleva poter rivolgersi a lei per dei consigli. Eppure ironicamente il momento in cui più desiderava averla con sé era anche il momento in cui non poteva averla.
“Madre, voglio che tu conosca il mio bambino. Mio figlio. Guwayne.”
La regina sgranò gli occhi per la sorpresa e sollevò la testa dal cuscino per vedere, per la prima volta, il piccolo Guwayne tra le braccia di Gwen.
La regina sussultò, si mise a sedere e scoppiò in singhiozzi.
“Oh, Gwendolyn, le disse. “È il bambino più bello che abbia mai visto.”
Allungò una mano e accarezzò Guwayne, mettendo le punte delle dita sulla sua fronte, quindi pianse con maggiore intensità.
La regina lentamente si voltò a guardare Thor.
“Sarai un bravo padre,” gli disse. “Mio marito ti adorava. Ora capisco perché. Mi sono sbagliata sul tuo conto. Perdonami. Sono felice che tu stia con Gwendolyn.”
Thor annuì solennemente, allungò una mano e strinse la spalla della regina.
“Non c’è nulla di cui chiedermi scusa,” le disse.
La regina si voltò di nuovo verso Gwendolyn e i suoi occhi si fecero più duri. Gwen vide qualcosa cambiare in essi, percependo la vecchia regina di un tempo.
“Devi affrontare molte questioni ora,” le disse. “Le ho considerate tutte io stessa. Ho ancora tutta la mia gente ovunque. Temo per te.”
Gwendolyn le accarezzò la mano.
“Madre, non preoccuparti per questo ora. Non è il momento per affari di stato.”
La regina scosse la testa.
“È sempre il momento per gli affari di stato. e ora soprattutto. I funerali, non dimenticarlo, sono affari di stato. non sono eventi di famiglia, ma occasioni politiche.”
Sua madre tossì a lungo, poi fece un respiro profondo.
“Non ho molto tempo, quindi ascolta attentamente le mie parole,” le disse con voce debole. “Imparale a memoria, anche se non vorresti udirle.”
Gwen si avvicinò di più e annuì solennemente.
“Qualsiasi cosa, madre.”
“Non fidarti di Tiro. Ti tradirà. Non fidarti della sua gente. Quei MacGil non fanno parte di noi. Appartengono alla nostra famiglia solo di nome. Non dimenticarlo.”
La regina ansimò, cercando di prendere fiato.
“Non fidarti neanche dei McCloud. Non pensare di poter fare la pace.”
La regina rantolò ancora e Gwen rifletté sulle sue parole, cercando di coglierne il senso più profondo.
“Tieni in forze il tuo esercito e consolida le tue difese. Più ti renderai conto che la pace è un’illusione, più pace ti assicurerai.”
Sua madre ansimò nuovamente, a lungo, chiudendo gli occhi e Gwen sentì spezzarsi il cuore vedendola in quello stato e constatando lo sforzo che stava facendo.
Da una parte Gwen pensò che quelle erano parole giuste nella bocca di una regina che stava morendo e che era da tempo stanca. Eppure, da un altro punto di vista, non poteva fare a meno di ammettere che c’era una certa saggezza in quel discorso, una saggezza che forse lei stessa non voleva riconoscere.
Sua madre aprì gli occhi di nuovo.
“Tua sorella Luanda,” sussurrò. “La voglio al mio funerale. È mia figlia. La mia primogenita”
Gwendolyn sussultò sorpresa.
“Ha fatto cose terribili meritandosi l’esilio. Ma concedile questa grazia, solo una volta. Quando mi metteranno sottoterra la voglio qui. Non rifiutare la richiesta di una madre morente.”
Gwendolyn sospirò, combattuta. Voleva accontentare sua madre, ma allo stesso tempo non voleva permettere a Luanda di tornare, non dopo quello che aveva fatto.
“Promettimelo,” le chiese sua madre, stringendole con forza la mano. “Promettimelo.”
Alla fine Gwendolyn annuì, rendendosi conto di non poter dire di no.
“Te lo prometto, madre.”
La regina sospirò e annuì, soddisfatta, poi si riadagiò tra i suoi cuscini.
“Madre,” disse Gwen schiarendosi la gola. “Voglio che tu dia la tua benedizione a mio figlio.”
La regina aprì debolmente gli occhi e la guardò, poi li richiuse e scosse lentamente la testa.
“Quel bambino ha già tutte le benedizioni che un bambino potrebbe desiderare. Ha la mia benedizione, ma non ne ha bisogno. Lo capirai, figlia mia: tuo figlio è molto più potente di te o di Thorgrin o di chiunque altro prima o dopo di voi. È stato tutto profetizzato anni fa.”
La regina ansimò a lungo e proprio quando Gwen pensava che fosse tutto finite, proprio quando si stava preparando ad andarsene, sua madre aprì gli occhi un’ultima volta.
“Non dimenticare ciò che tuo padre ti ha insegnato,” le disse con voce debole, quasi incapace di parlare. “A volte un regno è più in pace quando si trova in guerra.”
CAPITOLO SETTE
Steffen galoppava lungo la strada polverosa diretto a est una volta lasciata la Corte del Re. Era in viaggio ormai da giorni, accompagnato da una decina di membri della guardia della regina. Onorato di aver ricevuto un tale compito dalla regina e determinato a portarlo a compimento, Steffen si era spostato di città in città seguito da una carovana di carrozze reali, tutte cariche d’oro e argento, moneta reale, scorte per la costruzione, grano, mais, frumento e diverse provvigioni e materiale edile di ogni genere. La regina era determinata a portare aiuto a tutti i piccoli villaggi dell’Anello, aiutando a ricostruire, e in Steffen aveva trovato un emissario determinato.
Steffen aveva già visitato molti villaggi, aveva dispensato carri pieni di scorte per conto della regina, distribuendoli attentamente e precisamente tra i villaggi e le famiglie più bisognose. Si era sentito orgoglioso di vedere la gioia sui volti della gente mentre distribuiva e dispensava scorte e forza lavoro aiutando a ricostruire i villaggi che si trovavano attorno alla Corte del Re. Un villaggio alla volta, per conto di Gwendolyn, Steffen stava aiutando a riportare la fede nel potere della regina, nel potere della ricostruzione dell’Anello. Per la prima volta nella sua vita la gente guardava al di là del suo aspetto e lo trattava con rispetto, come una persona normale. Amava quella sensazione. La gente iniziava a capire che anche loro non erano stati dimenticati dalla regina e Steffen era entusiasta di essere una parte di questo aiuto stimolando l’amore e la devozione per lei. Non c’era nulla che avrebbe voluto di più.
Come il destino aveva predisposto, la rotta della regina stava portando Steffen, dopo molti villaggi, al suo paese natale, al luogo dove era cresciuto. Steffen provava un senso di timore, un vuoto nello stomaco rendendosi conto che il prossimo nella lista era proprio il suo villaggio. Avrebbe voluto voltarsi e tornare indietro, fare qualsiasi cosa per evitarlo.
Ma sapeva che non poteva. Aveva giurato a Gwendolyn di portare a compimento il suo dovere e ora c’era in ballo il suo onore, anche se ciò significava recarsi nel posto che animava i suoi incubi. Era il luogo dove si trovavano tutte le persone che aveva conosciuto crescendo, la gente che aveva goduto a tormentarlo, prendendolo in giro per il suo aspetto fisico. La gente che gli aveva fatto provare profonda vergogna per se stesso. Una volta andatosene aveva giurato di non fare ritorno mai più e di non rimettere più occhio sulla propria famiglia. Ora, ironicamente, la sua missione lo conduceva lì e gli richiedeva di predisporre per quel popolo qualsiasi risorsa di cui avessero necessitato, per conto della regina. Il destino era stato veramente crudele.
Steffen giunse in cima a una collina e da lì diede una prima occhiata alla cittadina. Gli venne un groppo allo stomaco. Solo a vederlo la sua autostima iniziò a vacillare. Stava cominciando a sentirsi più piccolo, a richiudersi in se stesso e quella era una sensazione che odiava. Si era sentito così bene, meglio di quanto si fosse mai sentito in vita sua, soprattutto data la sua nuova posizione, il suo seguito, il suo fare le veci della regina. Ma ora, di fronte a quel posto, gli tornarono alla mente le vecchie sensazioni di come la gente lo considerava. Odiava quella sensazione.
Quelle persone erano ancora lì? Erano crudeli come erano sempre state? Sperava di no.
Se si fosse imbattuto nella sua famiglia, cosa avrebbe detto loro? Cosa avrebbero detto a lui? Sarebbero stati orgogliosi vedendo la posizione che si era guadagnato? Aveva raggiunto una posizione e un rango più elevato di quello che chiunque nella sua famiglia o nel suo villaggio avesse mai raggiunto. Era uno dei consiglieri principali della regina, un membro del concilio reale. Sarebbero rimasti esterrefatti sentendo ciò che aveva conquistato. Alla fine avrebbero dovuto ammettere che si erano sempre sbagliati sul suo conto. Che lui non era inutile, dopotutto.
Steffen sperava che magari sarebbe andata così. Magari, finalmente, la sua famiglia lo avrebbe ammirato e lui avrebbe guadagnato una certa giustificazione tra la sua gente.
Steffen e la sua carovana reale giunsero fino ai cancelli del piccolo villaggio e Steffen li fece fermare tutti.
Si voltò poi a guardare i suoi uomini, una decina di guardie reali della regina, che lo fissavano tutti per avere istruzioni.
“Aspettatemi qui,” disse Steffen. “Fuori dai cancelli della città. Non voglio che la mia gente vi veda da subito. Voglio affrontarli da solo.”
“Sì, nostro comandante,” risposero.
Steffen smontò da cavallo, intenzionato a percorrere a piedi il resto della strada. Non voleva che la sua famiglia vedesse il suo cavallo regale e qualcuno del suo seguito della corte. Voleva vedere come avrebbero reagito vedendolo per chi era, senza sapere della sua posizione e del suo rango. Si tolse anche gli stemmi regali appuntati agli abiti nuovi strappandoli e lasciandoli appoggiati alla sella.
Attraversò a piedi i cancelli ed entrò nel piccolo e brutto villaggio che ricordava, sentendo l’odore dei cani selvatici, dei polli che scorrazzavano liberi nelle strade, delle vecchie signore e dei bambini che li rincorrevano. Passò oltre file e file di vecchie casupole, alcune fatte di pietra e la maggior parte di paglia. Le strade qui erano di condizione misera, piene di buche ed escrementi di animali.
Non era cambiato nulla. Dopo tutti quegli anni non era cambiato veramente niente.
Alla fine Steffen raggiunse l’estremità della strada, svoltò a sinistra e lo stomaco gli si serrò quando vide la casa di suo padre. Era come un tempo: una casetta di legno con il tetto spiovente e la porta sbilenca. Il ricovero sul retro era dove Steffen veniva costretto a dormire. A quella vista gli venne voglia di raderla al suolo.
Steffen camminò fino alla porta d’ingresso, che era aperta, si fermò lì davanti e guardò all’interno.
Gli si mozzò il fiato quando vide che tutta la sua famiglia era lì: suo padre e sua madre, tutti i suoi fratelli e le sue sorelle, tutti ammassati in quella casetta, come sempre. Erano tutti riuniti attorno al tavolo, come sempre, litigando per i rimasugli di cibo e ridendo tra loro. Con Steffen però non avevano mai riso. Se dovevano ridere, ridevano di lui.
Sembravano tutti più vecchi, ma allo stesso tempo erano uguali a una volta. Li guardò tutti con meraviglia. Lui era veramente parte di quella famiglia?
La madre fu la prima a notarlo. Si voltò e vedendolo sussultò e lasciò cadere il piatto che andò in frantumi a terra.
Il padre fu il secondo a girarsi, poi tutti gli altri lo fissarono scioccati di rivederlo lì. Erano tutti evidentemente dispiaciuti di vederlo, come se fosse appena arrivato un ospite indesiderato.
“Quindi,” disse il padre lentamente, accigliandosi e facendo il giro della tavola dirigendosi verso di lui e asciugandosi il grasso dalle mani con un fazzoletto in modo minaccioso, “alla fine sei tornato.”
Steffen ricordò che suo padre era solito fare un nodo a quel fazzoletto, inumidirlo e poi usarlo per frustarlo.
“Qual è il problema?” gli chiese con un sorriso sinistro in volto. “Non ce la facevi più nella grande città?”
“Pensava di essere troppo buono per noi. E ora se ne torna a casa come un cane!” gridò uno dei suoi fratelli.
“Come un cane!” gli fece eco una sorella.
Steffen stava fumando di rabbia e aveva il respiro pesante, ma si sforzò di trattenere la lingua e non scendere al loro livello. Dopotutto quelli erano dei provinciali, pieni di pregiudizi, il risultato di una vita trascorsa in un piccolo villaggio. Lui invece aveva visto il mondo e conosceva meglio le cose.
I suoi familiari – praticamente tutti nella stanza – ridevano di lui.
L’unica a non ridere, ma fissa a guardarlo con gli occhi sgranati era sua madre. Si chiese se magari lei potesse essere l’unica da salvare nel gruppo. Si chiese se magari potesse essere felice di vederlo.
Ma lei non fece che scuotere la testa.
“Oh, Steffen,” gli disse. “Non saresti dovuto tornare qui. Non sei parte di questa famiglia.”
Le sue parole, sciorinate con quella calma, senza malizia, gli fecero male più di tutto.
“Non ne è mai stato parte,” disse il padre. “È una bestia. Cosa ci fai qui, ragazzo? Sei tornato per avere più avanzi?”
Steffen non rispose. Non aveva il dono della parola, delle risposte veloci e di spirito, e certo non in un momento emotivamente forte come quello. Era così sconvolto da non riuscire quasi a dire una sola parola. C’erano così tante cose che avrebbe voluto dire a tutti loro, ma nessuna parola gli venne in mente.