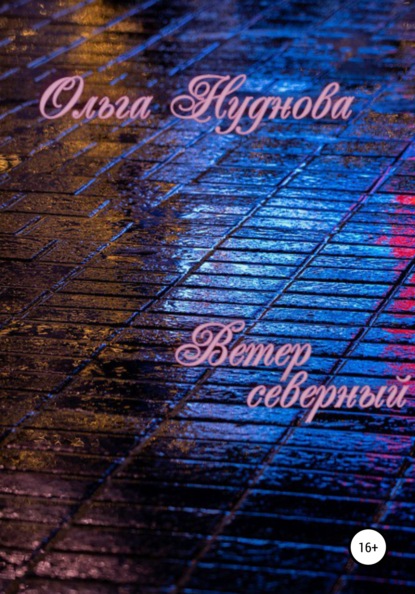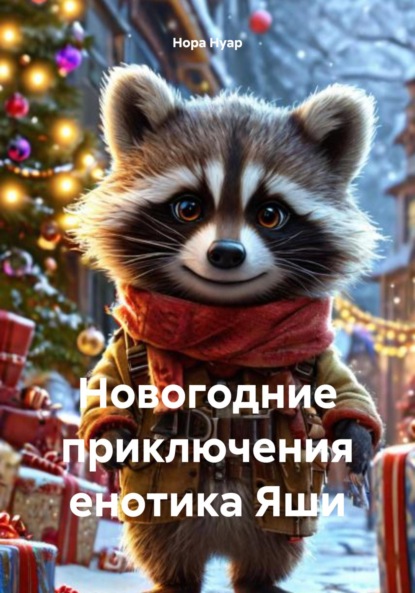Psicologia clinica. Corso Accademico di Lezioni
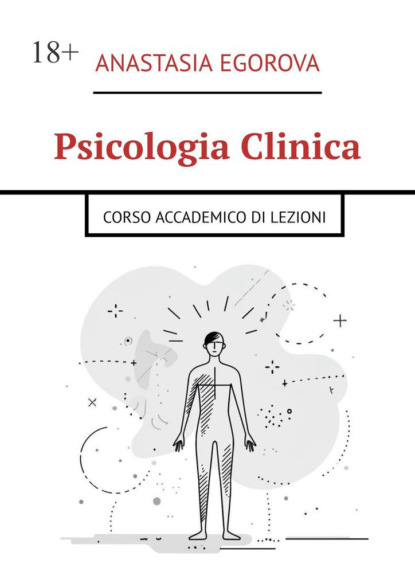
- -
- 100%
- +
Distinzione tra psicoterapia, psicocorrezione e riabilitazione
Dal punto di vista della psicologia clinica, è fondamentale distinguere concetti affini.
La psicoterapia (dal greco antico «cura dell’anima») rappresenta un’analisi approfondita dei problemi del cliente, orientata ai processi inconsci e alla ristrutturazione strutturale della personalità. La sua azione terapeutica non agisce sulla psiche in modo isolato, ma attraverso la psiche – sull’intero organismo umano. La psicoterapia favorisce la risoluzione di problemi emotivi, comportamentali e interpersonali, e il suo obiettivo finale è la trasformazione della visione del mondo e il miglioramento della qualità della vita.
La psicocorrezione (che significa «rettifica») è un complesso di metodiche finalizzate a correggere carenze della psicologia o del comportamento umano prive di base organica. La psicocorrezione accresce la flessibilità e l’adattabilità della psiche. La differenza cruciale rispetto alla psicoterapia risiede nel fatto che la psicocorrezione non persegue la modificazione della struttura della personalità e può rivelarsi efficace anche senza la piena consapevolezza da parte del cliente dei propri problemi.
Se la psicoterapia agisce sul mondo interiore e sulla visione del mondo, la psicocorrezione si concentra sull’eliminazione di specifiche carenze nello sviluppo psichico o di pattern comportamentali.
La riabilitazione si occupa del reinserimento nella vita sociale e professionale di persone che hanno sofferto di disturbi psichici o somatici. In questa fase si parla di prevenzione terziaria.
La riabilitazione non può essere ridotta a uno o due metodi di intervento (quali psicoterapia o ergoterapia) né descritta esclusivamente attraverso l’obiettivo finale (l’inserimento abitativo o lavorativo). Secondo l’approccio sistemico, la riabilitazione rappresenta un sistema dinamico di componenti interconnesse, costituendo simultaneamente sia metodo che fine.
Il concetto di riabilitazione proposto da M.M. Kabanov e implementato nelle cliniche dell’Istituto Psico-Neurologico V.M. Bekhterev di Leningrado possiede una sua storia specifica. Nato a metà degli anni ’20 dalle idee della «medicina fisica», si è arricchito dei progressi della psicologia medica, della pedagogia medica e della sociologia medica, strutturandosi sulla base dei principi della non costrizione e della terapia sociale.
Molti erroneamente riducono la riabilitazione a un «completamento della cura» o allo sfruttamento della residuale capacità lavorativa, il che restringe indebitamente questo concetto complesso. In conformità con le raccomandazioni dell’OMS, la riabilitazione è intesa come prevenzione terziaria (dove la primaria rappresenta la prevenzione in senso proprio, e la secondaria il trattamento). La riabilitazione costituisce innanzitutto un approccio fondamentalmente diverso alla persona malata.
Il concetto moderno di riabilitazione prevede un approccio integrale e complesso al paziente, che considera non solo le caratteristiche clinico-biologiche della malattia, ma anche i tratti personality e i fattori ambientali. Lo scopo della riabilitazione è il recupero dello status personale e sociale del paziente, indipendentemente dalla nosologia (sia esso un disturbo nevrotico, schizophrenia, infarto miocardico o patologie dell’apparato muscolo-scheletrico).
La selezione degli strumenti diagnostici è effettuata dallo psicologo clinico in modo individualizzato, in base agli obiettivi specifici. Lo specialista opera nel quadro degli standard professionali, ma assume la piena responsabilità della scelta metodologica.
Gli psicologi clinici esperti (con oltre 10 anni di esperienza) detengono il diritto all’adattamento metodologico: possono applicare metodi standardizzati in versione non standardizzata per l’analisi qualitativa delle caratteristiche dell’attività psichica, qualora ciò sia giustificato dagli obiettivi diagnostici e dall’esperienza professionale.
Oltre ai metodi patopsicologici, per risolvere compiti diagnostici, specialmente in neurologia, neurochirurgia e nella pratica pediatrica, vengono utilizzati metodi neuropsicologici. Questi sono finalizzati allo studio delle caratteristiche del linguaggio, della gnosi visiva, uditiva e tattile, e consentono di identificare la specificità dei deficit della memoria a breve e lungo termine, compresi quelli con predominanza patologica in una specifica modalità (visiva, tattile, uditiva). Sono particolarmente diffuse le varianti non standardizzate dei metodi neuropsicologici, sebbene vengano impiegati anche strumenti standardizzati come la diagnostica secondo L.I. Vasserman.
Dal punto di vista degli psicologi clinici, nella scelta del metodo psicologico è necessario guidarsi secondo i seguenti principi:
1. Scopo della ricerca. Se l’obiettivo è la diagnosi differenziale, la determinazione della profondità del difetto psichico o lo studio dell’efficacia terapeutica, la scelta del metodo è determinata dalle caratteristiche del disturbo presunto. Ad esempio, in caso di sospetto disturbo del pensiero, lo psicologo clinico opterà non per il test di Rorschach bensì per il metodo delle pittogramme di A.R. Luria, che consente di evidenziare problematiche nell’attività pensante e valutare la memorizzazione mediata.
2. Istruzione ed esperienza di vita del paziente. Nella selezione della metodica, lo psicologo clinico è tenuto a considerare il livello di istruzione, il bagaglio esperienziale e l’anamnesi del paziente. Metodiche diagnostiche complesse possono rivelarsi inefficaci per una persona dedita al lavoro manuale. Ad esempio, un compito sulla formazione di analogie complesse risulterebbe inappropriato per un paziente privo della relativa esperienza cognitiva.
3. Caratteristiche del contatto con il paziente. La scelta metodologica dipende dalle peculiarità della relazione con il malato. Ad esempio, nell’esaminare pazienti con deficit dell’analizzatore uditivo, è più opportuno utilizzare compiti basati sulla percezione visiva.
Nel processo di ricerca, gli psicologi clinici generalmente impiegano compiti progressivamente più complessi. Fanno eccezione i casi in cui si sospetti pseudodemenza, aggravamento o simulazione. In presenza di sospetta simulazione, lo psicologo potrebbe somministrare intenzionalmente un compito complesso per verificare la propria ipotesi.
Tra le giovani generazioni di studenti, purtroppo, si è diffusa una moda di simulare patologie psichiche. Se alcuni anni fa manifestavano prevalentemente sintomi di disturbo ossessivo-compulsivo o depressivo, oggi sono diventati di moda sintomi patopsicologici caratteristici della schizofrenia lentamente progressiva o del disturbo bipolare. Tali casi sono particolarmente tipici negli adolescenti con personalità isteroide, che sperimentano carenza di attenzione. Questi adolescenti possono trarre in inganno non solo psicologi clinici, ma anche psichiatri, il che occasionalmente conduce a ricoveri ingiustificati per osservazione.
B.V. Zeigarnik sottolineava che condurre una ricerca patopsicologica in ambito clinico è significativamente più complesso che in ambiente naturale. Gli esperimenti patopsicologici non mirano a misurare processi isolati, bensì a studiare l’essere umano nel processo dell’attività reale. Essi presuppongono l’analisi qualitativa delle varie forme di disintegrazione psichica, l’identificazione dei meccanismi sottostanti i deficit funzionali e la ricerca di possibili strategie di recupero.
Poiché ogni processo psichico possiede una dinamica e una direzionalità intrinseche, le indagini sperimentali devono cogliere la preservazione o l’alterazione di tali parametri. I risultati sperimentali devono privilegiare una caratterizzazione qualitativa, non limitandosi a quella quantitativa. Ripetute somministrazioni testologiche che si limitano a constatare una «disintegrazione della personalità» risultano inefficaci senza un’adeguata descrizione dell’evoluzione sintomatologica.
I risultati delle indagini patopsicologiche devono garantire affidabilità. L’elaborazione statistica dei dati viene applicata solo ove appropriato, essendo l’analisi quantitativa complementare ma non sostitutiva di quella qualitativa. Come sottolineava Zeigarnik, risulta essenziale considerare non solo le prestazioni del paziente, ma anche la sua comprensione dei compiti, le interpretazioni fornite e le cause soggiacenti agli errori commessi.
L’analisi qualitativa degli errori, andando oltre la loro mera rilevazione, fornisce il materiale più significativo per valutare le caratteristiche del funzionamento psichico dei pazienti. L’impostazione della ricerca psicologico-sperimentale in ambito clinico si distingue dall’esperimento psicologico convenzionale per il ricorso a una metodologia plurima, atta a indagare un processo di disintegrazione psichica che non si presenta mai come monodimensionale.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.